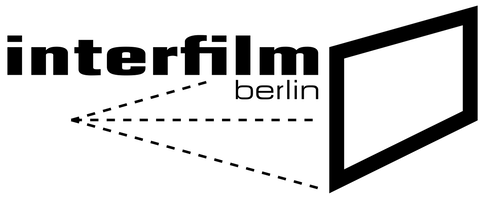Vittorio
De Seta
biography
Tra il 1954 e il 1995 in modo assolutamente indipendente e oserei dire avventuroso, con l'intuizione di essere testimone di un cambiamento epocale, Vittorio De Seta irrompe nel panorama cinematografico italiano con una serie di cortometraggi, allora si chiamavano documentari, sulla Sicilia. Una terra periferica, lontana dalla modernità, dove sopravvivevano scampoli di riti millenari, in cui il lavoro era ancora espressione di una cultura rispettosa della natura e delle sue leggi.
Quello che colpisce di questi film, oltre all'evidente urgenza narrativa – sei cortometraggi in poco più di un anno – è l'apparente contraddizione tra uno stile sorprendentemente innovativo (assenza del commento fuori campo, uso creativo del sonoro e del cinemascope) e l'adesione del regista alle ragioni profonde della civiltà contadina, antitetica al vincente, "moderno", modello di sviluppo industrialista, lo "sviluppo senza progresso" come lo definì Pasolini. Contadini che trebbiano con i muli, pescatori di pesce spada di vedetta, minatori di zolfo seminudi che non vedono mai il sole, o altrettanto epiche donne che lavano i panni in riva al mare, vengono colti da De Seta nei momenti cruciali del loro rapporto con il mondo naturale, che si esprime soprattutto durante il lavoro. Non si tratta di istanti qualsiasi ma di gesti che suscitano pose statuarie in cui si scorge il debito che l'autore ha verso il cinema classico soprattutto quello di Eisenstein.
De Seta continua la sua ricerca in Calabria e in Sardegna dove realizza il suo film più conosciuto: Banditi ad Orgosolo che lo porterà all'attenzione del grande pubblico. È un'opera lontana dall'esperienza neorealista, nel cui alveo è stato spesso ricondotta; qui non vi sono attori, professionisti o non, in ruoli che non corrispondono alle loro vite reali. I protagonisti interpretano loro stessi e contribuiscono allo sviluppo narrativo del film. Qui come nei cortometraggi, il paesaggio ha un ruolo determinante, si vive nei boschi, tra gli animali in un continuo interscambio con un mondo selvatico a cui ci si rapporta a volte con violenza ma sempre all'interno di un ordine naturale superiore. Gli anni Sessanta del boom economico sono, per De Seta, anni di crisi e ricerca interiore che producono due film, bollati dalla critica "progressista" del tempo con l'opinabile definizione di "intimisti". Ritorna a temi più esplicitamente sociali nei primi anni Settanta con Diario di un maestro e Quando la scuola cambia, ancora nel segno dell'innovazione, con due casi riusciti di televisione alta e nello stesso tempo di larga audience. Ma è con La Sicilia rivisitata e In Calabria che De Seta esprime la sua indignazione verso lo scempio culturale e ambientale che la rottura degli equilibri naturali hanno determinato. Tradizioni, culture, comunità, paesaggi sono state spazzati via da colate di cemento, da fabbriche presto ridotte a scheletri, da pontili giganteschi in porti deserti, da camion e ruspe giganti. Lui punta la macchina da presa e si riappropria della voce fuori campo per dire: "Che bisogno c'era?".
(Gaetano Capizzi)