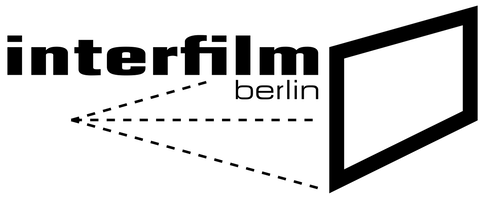Tiden har inget namn
Diretto da
Manifesto di Stefan jarl
Incominciamo dall'inizio.
Che cos'è un documentario? Esattamente cosa caratterizza un documentario?
Ci sono tre criteri:
- non c'è Julia Roberts;
- se entrate in un cinema ed è completamente vuoto, potete essere sicuri che stanno proiettando un documentario;
- se c'è una persona come pubblico e non sta ridendo, potete essere ugualmente certi che c'è un documentario.
Scherzi a parte, i documentari vengono generalmente associati al cinéma-vérité. Cinéma-vérité è un film che è insieme obiettivo ed accurato. Quello che vediamo è la verità, filmata dal cineasta in una certa sequenza. Le scene passano davanti ai nostri occhi, messe insieme in maniera obiettiva, più vicine possibile alla reale sequenza di eventi. Ecco come ai cineasti piace vedere la situazione; vedono il cineasta come il cosiddetto Testimone Fedele.
Niente può essere più lontano dalla realtà. Non esiste una cosa come un documentario accurato e obiettivo. Il cineasta influisce sulla situazione nel momento stesso in cui entra in una stanza con una cinepresa. Avviene una immediata trasformazione psicologica. Qualcuno non vuole essere filmato e qualcun altro pensa: "Perché non mi sono lavato i capelli?"; un altro è nel bel mezzo di progetti per una carriera hollywoodiana e aspetta solo di essere scoperto ecc. Se il cineasta e la macchina da presa non fossero stati nella stanza in quel momento non sarebbe successa nessuna di queste cose.
Lo spettatore intelligente è cosciente di tutto questo. Le scene di un film non sono mai mostrate nell'ordine in cui sono state riprese. Vengono sempre riarrangiate per soddisfare il proposito del regista. Un regista è un manipolatore. Egli sistema le scene nel modo migliore per lui. Questo è il motivo per cui il pubblico è lì. Un pubblico è destinato ad essere manipolato. Più manipolazione c'è e meglio è. "lo non faccio documentari obiettivi ed accurati, io faccio film", dice l'americano Robert Wiseman, che è stato probabilmente il nome più associato al cinéma-vérité di chiunque altro in tempi moderni.
Non c'è alcuna differenza tra un documentario e un film. Tuttavia, la natura di ognuno di essi è diversa. Tutti e due sono nati per far sì che i registi potessero esprimersi. C'è sempre una persona dietro alle immagini sullo schermo argentato e più facile è scorgere la persona e meglio è.
Il regolamento della televisione nazionale svedese stabilisce che i documentari televisivi debbano essere obiettivi ed accurati. Se non lo sono, la televisione nazionale svedese non li manda in onda. lo odio la televisione e non la guardo mai. Non ho mai fatto un film per la televisione per un motivo molto semplice: odio l'obiettività e la verità. I miei film sono soggettivi, essi esprimono la mia verità. Il mondo e il modo in cui viene presentato è direttamente collegato a come io lo sento. Le altre persone e le loro esperienze non hanno niente a che fare con questo. La mia percezione consiste nelle cose che vedo e cosa io considero importante, non quello che gli altri vedono e pensano. Inoltre io voglio influenzare gli altri usando quello che ho visto.
Quello che ho visto è importante da vedere e inoltre la mia visione di quello che ho visto è più valida della percezione degli altri riguardo a questo. Per dire la verità io voglio che tutti gli altri vedano le cose come le vedo io.
lo faccio film perché voglio influenzare gli altri.
Il regista che afferma che sta facendo un film obiettivo ed accurato, in altre parole il regista televisivo, è disonesto e ipocrita. Tali registi vogliono che noi crediamo che essi ritraggono l'unica immagine vera della realtà. Questo non è vero. Di fatto sono falsi, la verità è che stanno facendo il gioco del cliente. Fanno come gli viene detto e si aggrappano all' obiettività e alla verità. La cosa peggiore è che chi dà gli ordini, la televisione svedese di Stato, cioè il governo svedese, tiene il potere. II regista obiettivo e fedele esegue la volontà del potere.
Chi vuole guardare film che esprimono i valori e le gerarchie del potere? I miei film non sono parte di un mondo di false congetture e accordi. Essi appartengono all'orgogliosa tradizione europea della ribellione; i miei film rappresentano un altro modo di guardare e di percepire la realtà. Stanno dalla parte dell'uomo comune. E non solo, essi pretendono di essere la voce della gente comune, la gente di cui raramente sentiamo la voce. Ecco perché l'uomo della strada è il mio protagonista.
Un buon documentario è buono solo se è buono il rapporto tra le persone davanti alla cinepresa e quelle dietro. Cattive relazioni creano film brutti. Ogni persona ha la sua storia personale che merita di essere trasformata in un film ma pochi film toccano tali argomenti.
Nel 1922 il film di Flaherty Nanook apparve in Svezia. Fu un grande successo. Più di 75 anni dopo io ebbi la fortuna di avere un'esperienza simile con il mio film Una vita rispettabile. Diventò uno dei film più famosi nella storia dei documentari svedesi. Come Nanook, tratta di persone comuni e questa è la ragione della sua unicità. Dopo il successo, Flaherty ricevette molte offerte per fare altri film tipo Nanook. Qualcuno gli parlò di un'isola chiamata Aran nell'oceano Atlantico. Si diceva che la gente laggiù conducesse una vita molto dura basata soprattutto sulla pesca.
Flaherty andò sull'isola per fare un documentario su questo popolo povera ma laborioso. Quando arrivò sull'isola, capii che le cose che aveva sentito sui suoi abitanti erano assolutamente false. La gente aveva messo a terra le sue strette barche di legno e non le usava da molti anni. Gli erano state raccontate storie di un'epoca ormai passata. Cosa doveva fare? Doveva tornare a casa? Flaherty versò una lacrima e andò a fare una passeggiata. Aveva fatto tanta strada e dopo tutto poteva anche fare un film. Anche se stavano incominciando a fare acqua, le vecchie barche non erano completamente marcite. Riuscì a trovare un paio di vecchi pescatori nel pensionato che non si erano completamente dimenticati di come si manovravano le vecchie barche. E allora, perché non andare avanti come era stato progettato? I vecchi sulle enormi onde avrebbero fatto una grande impressione sulla pellicola! Sarebbe sembrato come se stessero rischiando le loro vite per guadagnarsi da vivere. Fidatevi: era un grande documentario, pieno di azione e di scene da far stare con il fiato sospeso. Mangiati il fegato Arnold Schwarzenegger: nell'Uomo di Aran c'è già tutto! Non c'è niente che Flaherty non abbia fatto. Egli è il padre del documentario creativo e io vado avanti nella stessa tradizione.
lo giro i miei film usando pellicole 35 mm e suono Dolby Stereo. In Svezia, dove sono nato, l'85% dei film sono di origine americana. Sono pienamente cosciente di questo fatto e so che devo competere contro questi film per il mio pubblico. Devo essere abile nell'attrarre gli spettatori come lo sono i registi americani. lo non ho niente contro la competizione: ho visto l'inizio di Jurassic Park quaranta volte.
Non posso negare che competere con i film americani è arduo, soprattutto se si è fuori dalla sfera del business della cinematografia commerciale e i giganteschi monopoli della televisione. Non è facile ottenere capitali per la produzione. Devi finanziare il film che vuoi fare con i soldi sui quali riesci a mettere le mani, innanzitutto dal tuo pubblico. Tutto quello che resta da fare quando quel denaro finisce è prendere qualsiasi denaro sul quale riesci a mettere le mani.
lo chiamo tutto questo la "strategia di Robin Hood". Prendo ai ricchi e do ai poveri più vicini al mio cuore, cioè io. Qualche volta la mia strategia funziona così: corteggio agenzie governative e organismi simili che controllano grosse somme di denaro. Dico loro che voglio fare un film sulle attività della loro agenzia governativa e mostrare il loro lavoro nella migliore luce possibile. Offro loro i miei servizi come regista commerciale e li convinco che sono quello che può realizzare un eccezionale ritratto della loro attività. Per il direttore di un'agenzia questa è musica per le proprie orecchie. Poi uso i soldi che ottengo per fare i miei film. Per esempio, se ricevo fondi dall'Agenzia Svedese per la Protezione dell'Ambiente li uso per fare un film che critica l'agenzia per la Protezione dell Ambiente in Svezia. Fare un buon film è molto importante. Altrimenti un'agenzia governativa potrebbe girare la faccenda alla polizia e sostenere che li ho truffati. Potrebbero persino mandarmi in prigione. Tuttavia, se si fa un film di notevole importanza che magari vince un premio ad un festival internazionale rinomato, le autorità non sono inclini ad infastidirti. Tutti amano un vincitore, no? Robin Hood non era affatto preoccupato di essere ricercato dal governo, e nemmeno io lo sono.
Questo tipo di strategia funziona solo se tu sei il tuo stesso produttore, sceneggiatore, regista, distributore e proprietario di sala cinematografica. lo sono tutte queste cose. Sono stato coinvolto nel fondare una compagnia di distribuzione non commerciale chiamata Film-Centrum e una catena di sale cinematografiche corrimerciali nota come Folkets Bio nel mio paese. Per esempio Da emarginati a yuppie è in programmazione in uno dei nostri cinema a Stoccolma mentre scrivo questo. Adesso è al terzo anno. Ho ricevuto l'European Academy Award per questo film nel 1993.
Ci sono molti problemi più sottili nel fare documentari oggi. Uno di questi è che nessuno vuole essere considerato un regista di documentari. Tutti vogliono essere pensati come creatori di film. Oggigiorno i registi fanno documentari mentre aspettano la chance di fare il loro primo film. Le scuole di cinema iniziano con i documentari come esercizi prima che gli studenti si dedichino alla cosa vera, cioè film di fiction. Il governo svedese sovvenziona film ad una percentuale dieci volte maggiore della somma devoluta per le produzioni di documentari. I documentari vengono raramente recensiti sulle pagine d'apertura e un documentario può anche non essere recensito per niente. I libri di cinema quasi mai parlano di documentari. La gente tende a pensare a loro come film di serie B, una specie di sottoproletario dell'arte cinematografica.
L'idea che il documentario appartenga al "canale di scolo" è comune tra l'élite e questo può far diventare matta anche la persona più insensibile. Rappresentare la realtà non è di moda. Forse è perché siamo così saturi di informazioni oggi che non riusciamo ad assorbire altra realtà. La gente cerca di rilassarsi, cerca la fuga, l'anti-realtà e la fiction. Cosa succede ad una società che non è più disposta a vedere?
Secondo me è una benedizione che i documentari siano nel canale di scolo. Quello è il posto al quale appartengono: i documentari dovrebbero stare in posti come fabbriche sporche, case per anziani, miniere di Sarajevo, fogne e corridoi di ospedali. I documentari dovrebbero stare anche nelle case degli affamati e dei disoccupati, con i vagabondi e gli emarginati, nei posti bui, sulle panchine dei parchi, nelle prigioni, con gli oppressi, gli sfruttati, con quelli che abbiamo privato di tutto e con le persone che non hanno voce – invisibili e inascoltate –, i documentari dovrebbero riguardare il cortile sul retro della società, la casa dei ragazzi che vivono per strada.
Questa è la missione storica e il fato del documentario. Tali film non possono aspettarsi di attrarre gli spettatori nelle belle sale cinematografiche della città.
Sta diventando difficile per i documentari sopravvivere nei cinema. Le televisioni girano loro le spalle sempre più spesso. Gli stessi richiami per l'intrattenimento stanno riecheggiando per tutta Europa.
Paura di essere onesti e anche di parlare in tutta onestà. Non dobbiamo permettere al documentario di scomparire. Se questo succede, come possiamo proteggerci contro il pregiudizio, i giudizi sbagliati, i miti e la disinformazione?
Approfondimento
A proposito di Time Has No Name
Stefan Jarl partigiano e poeta
Quando ripenso a quella mattina, ricordo che per i primi venti minuti ero seduto là, sentendomi un po' ansioso, quasi spaventato. Ero seduto e mi chiedevo se avevo fatto qualcosa di sbagliato. Ero arrivato tardi? No. Era forse qualcosa che avevo detto all'inizio dell'intervista? L'avevo iniziata con un argomento delicato o non appropriato? Mi ricordo che pensavo a queste cose.
Stefan Jarl sedeva davanti a me, sputando e sibilando come un cobra arrabbiato, in mezzo a una gran confusione di poster, bobine vuote e mobili messi a caso. In una piccola e buia sala di montaggio a Gamla Stan, il vecchio quartiere di Stoccolma, sfogava la sua rabbia accumulata verso l'industria cinematografica come un vulcano in eruzione.
Quando trascrissi l'intervista ero un po' preoccupato che Jarl potesse non essere disposto ad avallare tutti gli insulti e le ingiurie che aveva pronunciato. La maggior parte degli intervistati fa così. Dire qualcosa nel corso di un'intervista è una cosa, ma riconoscerla nero su bianco è tutt'altra cosa. Così fu con qualche ansia che gli mandai quello che avevo scritto. Jarl mi telefonò il giorno dopo. "Va bene, ma lo hai ammorbidito un po' in un paio di punti. Se lo rendi più caustico, sarà più chiaro e forte".
Ricordo un ampio sorriso sulla mia faccia. Questo episodio fu nella primavera del 1985, proprio dopo che Själen är större än världen (L'anima è più grande del mondo, 1985) era stato presentato al Festival di Berlino. Fu la mia prima intervista con Stefan Jarl, la prima volta che lo incontrai. Ma l'impressione che ne ricevetti allora, che avesse davvero un caratteraccio, è stata poi confermata in numerose altre occasioni.
Potrebbe sembrare una semplificazione, ma gli ostacoli e i rifiuti sono una forza motrice per Jarl. Essi sono l'origine della rabbia che era sgorgata da lui nel corso di quell'intervista e anche della lotta che lo vede impegnato praticamente ogni giorno dagli ultimi 25 anni. È a ragione che viene descritto, in una delle opere svedesi sul cinema più accreditate, come un cineasta che “è sempre in disaccordo con l'establishment”. Iniziò con le discussioni sulla censura di Dom kallar oss mods (Ci chiamano emarginati. 1968) e da allora continua. Da questa opposizione sono emerse la sua estetica e la sua filosofia sul cinema. A parte pochi infelici mesi come responsabile di progetto allo Svenska Institutet, Jarl non è mai stato attratto a fare nient'altro che il regista indipendente. Una cosa che ha imparato nel corso dei suoi primi conflitti con l'industria televisiva e con quella cinematografica, fu che è necessario avere il controllo totale sull'intera produzione, dalla sceneggiatura iniziale al film finito. È stato per questa ragione che Jarl, insieme a pochi altri registi, ha costruito una sorta di piattaforma e ha cercato di prendere il controllo dei suoi mezzi di espressione: i film. Il Film-Centrum garantiva una distribuzione non commerciale, la Folkets Bio dava la possibilità di presentare i loro film nei cinema commerciali; mentre una pubblicazione, "Film & TV", assicurava che il dibattito rimanesse vivo e impediva alle autorità costituite di nascondersi dietro alle loro scrivanie. Ma i soldi che venivano dalla distribuzione non erano mai sufficienti per permettere la produzione di nuovi film. Oggi, vent'anni dopo, bisogna ammettere che le crepe sono evidenti nella piattaforma che doveva garantire la libertà di espressione. Più del 75% dei film presentati nei cinema sono americani, tutte e quattro le reti svedesi sono inondate da telefilm americani e la Folkets Bio (Il cinema della gente) è stata resa più o meno inoffensiva.
I film di Jarl sono fatti nella tradizione europea di resistenza e ribellione. Essi cercano di raggiungere qualcosa che va al di là di quello che si vede sullo schermo. Sono film che vogliono dare un contributo per il cambiamento. Sono film di lotta. Il pubblico dovrebbe riflettere su quello che ha visto. Dovrebbe pensare: "le cose non possono andare avanti così", "voglio saperne di più" o "devo essere coinvolto in tutto ciò. Questo è quanto Jarl vuole e cita Strindberg: "L'utilità viene prima della bellezza".
Il suo scopo durante tutta la sua carriera cinematografica è stato di influenzare gli altri. Ma chiunque abbia visto film come Hotet (La minaccia, 1987), Tiden har inget namn (II tempo non ha nome, 1989) e Goda människor (La gente buona, 1990), sa che ci sono scene di commovente bellezza, perché Jarl è conscio dei termini sui quali deve competere. Se si vuole arrivare alla gente abituata all'alta qualità tecnica delle grandi produzioni americane, allora qualsiasi cosa venga fatta, deve essere fatta straordinariamente bene. Un'altra ragione è chiaramente il rapporto di Jarl con le arti visive. Mi resi conto di questo nella primavera del 1989 quando andai con Jarl al "Cinéma du Réel", il festival del documentario di Parigi, dove doveva essere presentato Il tempo non ha nome. Il pomeriggio prima della proiezione Jarl mi portò a fare un giro nei negozi e nelle gallerie d'arte. Curiosammo per ore e Jarl comprò un gran numero di libri su Picasso, Bruegel, Degas, Van Gogh e libri di fotografia documentaristica. [...] Mi ricordai di una conversazione che avevo avuto poche settimane prima nel corso di un'intervista con il cameraman e collega di Jarl, Per Källberg, durante la quale egli raccontò di come Jarl, all'inizio della loro collaborazione durante le riprese di Ett anständig liv (Una vita rispettabile, 1979), definì il suo approccio con l'immagine: "Mi trascinò per mostre d'arte. Molto aveva a che fare con la luce e il trattamento della luce. Guardammo Van Gogh, Rembrandt, Roj Friberg e altri, le cui immagini avevano un'espressività speciale, mentre allo stesso tempo giravamo per la città in cerca di tossicodipendenti...".
Tutta la grande arte ha aperto gli occhi del pubblico e ha fatto sì che percepisse la società e l'ambiente in modo nuovo. Jarl è totalmente convinto di questo. Lui citerebbe volentieri un'altra divinità, Walter Benjamin: "L'arte che inizia a dubitare della sua missione e cessa di essere ‘inséparable d'utilité’ (Baudelaire) è obbligata a cedere l'orgoglio alla novità".
Jarl non vede nessuna contraddizione tra arte e scienza, al tempo di Leonardo da Vinci (suo grande idolo) erano un tutt'uno. A quei tempi Leonardo da Vinci stava sveglio tutta la notte per analizzare corpi e disegnare vasi sanguigni e muscoli per poter fare dei buoni disegni di persone durante il giorno. Ecco dove Leonardo da Vinci ha toccato quel tipo di ideale che si incontra di tanto in tanto in un documentario: l'esploratore.
Ma Jarl vuole portare oltre il ruolo dell'arte. Non dovrebbe essere solo utile nel senso di influenzare le persone e far cadere davanti ai loro occhi le scale di valori. Dovrebbe anche, spera, essere in grado di cambiare la stessa situazione di produzione. Walter Benjamin e Bertolt Brecht forse sono stati i suoi precursori, ma queste idee sono basate sulle esperienze dei suoi primi anni e sono state pagate a caro prezzo. Sono i termini della produzione che governano tutta l'espressione ed è vitale cambiarli e ottenerne il controllo durante il corso della gestazione di un film.
Fu anche a Parigi che sentii Jarl parlare dell'espressività per la prima volta. Non è quello che un'immagine sembra o come viene prodotta che è importante, ma quello che esprime. Anche questo è diventato parte del metodo di lavoro estremamente idiosincratico di Jarl e Per Källberg "Prima di ogni ripresa, Stefan viene e parla per un bel po'. Principalmente è una discussione filosofica: cosa dovrebbe esprimere globalmente e cosa dovremmo fare per portarla fino a quel punto. È estremamente importante perché anche prima che le riprese abbiano inizio, so quale atmosfera ci si aspetta che le immagini suggeriscano. È un prerequisito che serve per capirle in modo globale".
Durante le riprese vere e proprie, Jarl lascia Kallberg alle prese con il suo lavoro. Quando sa che Källberg sa che cosa deve esprimere l'immagine, raramente si preoccupa anche solo di guardare nel mirino. È quasi commovente ascoltare il dialogo tra Stefan e Per durante e dopo una ripresa. Suona più o meno così: "Buona, Per? Che ne pensi?". Al che Per risponde: "Mhm... sì, abbastanza buona". Questo naturalmente non vuol dir nulla per un esterno. Ma dal tono della sua voce Jarl può immediatamente dedurre che cosa c'era che non andava e se è necessario girare di nuovo. Questo è il frutto prezioso ed affascinante di molti anni di collaborazione. Mostra anche la fiducia che essi hanno l'uno nell'altro e che è nata dalla profonda relazione di due persone con il concetto di immagine. "Semplicemente ci piace lo stesso tipo di quadri, questo è tutto", riassume Per laconicamente.
Jarl sostiene che l'arte riguarda soprattutto l'essere diligenti: diligenza e lavoro duro. Questo è un atteggiamento che ha evidentemente ereditato da suo padre, Håkan Jarl. Stefan scherza spesso sul modo in cui era solito concludere il lavoro di una giornata (che spesso durava 16 ore), con le parole: "Non dormi mai così bene come quando hai fatto quello che dovevi fare". Così Jarl è convinto che bisogna andare sul posto di lavoro tutti i giorni alle otto di mattina e mettersi a lavorare. Questo è necessario anche se si sta seduti lì, giorno dopo giorno, a chiedersi perché si è lì. L'ispirazione certamente esiste ma viene sprecata se non si va a lavorare. Jarl di solito menziona l'autore di Stoccolma Stig Claesson come esempio, un uomo che ha scritto 52 libri, dipinto molti quadri ed è andato a lavorare tutte le mattine alle otto. "Tutte le grandi opere sono prodotte da pugni stretti", come disse Goethe una volta.
L'arte dovrebbe anche essere difficile. Fondamentalmente l'arte è una manifestazione di come uno si complica le cose. Jarl dice spesso a Per Källberg: "Dobbiamo renderlo molto più complicato. Perché stai riprendendo quello? O lo facciamo completamente diverso o torniamo qui domani. Oppure lo facciamo quando non ci saranno supposizioni!". Ancora una volta intravediamo il suo caratteraccio. Se sembra ovvio prendere una strada particolare, lui mette immediatamente un segnale di pericolo e va dall'altra parte.
Questo rapporto esigente e difficile con il lavoro ricorre in tutti i film di Stefan Jarl. È evidente in L'anima è più grande del mondo, un film grandemente fisico sulla lotta nella quale il conflitto e il percorso sono più importanti della meta. È anche illustrato nell'omaggio che Jarl rende all'agricoltore in Il tempo non ha nome che è introdotto da alcune parole di Pier Paolo Pasolini: "Non c'è altra poesia se non quella delle azioni concrete".
Jarl dice spesso che ha imparato sette cose da Ingmar Bergman. Non so quali siano le altre sei, ma la settima è il grande vantaggio, artisticamente parlando, di lavorare con la stessa squadra da un film all'altro. Da Una vita rispettabile il cameraman Per Källberg, il montatore Annette Lykke Lundberg, il musicista e compositore Ulf Dageby e Per Carleson, il tecnico del missaggio, formano la "Banda dei Quattro" che circonda il regista Stefan Jarl. Con tutti loro egli ha sviluppato un metodo di lavoro personale ed ostinato nel quale la parola chiave è "fiducia". Un metodo di lavoro, o più correttamente un faccia a faccia ideologico cercato a tutti i livelli della gestazione di un film, è quello che Jarl chiama "la posizione neutrale". Significa che, dopo aver girato i giornalieri nella location, ci si siede in sala montaggio e si vede da capo che cosa esprimono le immagini. Questo lavoro è il più straziante e distruttivo per la propria autostima: essere obbligati ad ammettere che la luce nordica su questa foresta o quel mare era di fatto un'immagine piatta e senza vita. Poi sorgono le domande autocritiche: a cosa stavo veramente pensando? Sono totalmente privo di talento? Come diavolo metterò insieme tutto questo? Tutto ciò riguarda l'immagine che ha una sua vita propria. Là, nella sala di montaggio, insieme ad altre immagini che la precederanno e la seguiranno, l'immagine esprime se stessa in modo diverso. Può darsi che sia assolutamente appropriata quando posta nel suo contesto, ma più spesso, per sfortuna, è completamente inutile.
Jarl è ugualmente spietato con se stesso quando inizia l'importante e delicato lavoro con la musica e il suono. Un altro elemento viene aggiunto alla totalità e nascono nuove espressioni. È un continuo filtrare e distillare nuove impressioni grazie alle quali, con un po' di fortuna, qualsiasi cosa contribuisca all'opera finita e abbia una porzione dello schermo, è la cosa più vicina alla verità che si possa avere. Forse questo è ciò che il guru e mentore di Jarl, Arne Sucksdorff – che ricevette un Oscar nel 1949 per il suo cortometraggio Människor i stad (Gente di città) – chiama "il giusto equilibrio tra verità documentaristica e verità poetica". È questa complessa verità, questa composita descrizione della realtà che Stefan Jarl ricerca continuamente nelle sue immagini e nelle sue forme. Egli rifiuta completamente il mito del cinéma-vérité, in parte perché ovviamente non c'è nessuno che abbia un rapporto obiettivo con una realtà esterna. Il fatto stesso che la cinepresa sia messa in un posto particolare significa che è stata fatta una scelta. Frederick Wiseman, la persona che più viene associata al cinéma-vérité, trascorre un anno nella sala di montaggio per ognuno dei suoi film. Possiamo supporre che nessuna pretesa di obiettività venga abbandonata durante questo periodo Comunque questo è qualcosa che non ha mai cercato di negare! Ma la ragione principale del rifiuto è che la realtà è più complessa del filmare un evento. Il contadino che ara il suo campo, il sami che macella la sua renna, il tossico che si buca o lo sportivo solitario durante l'allenamento, ognuno di loro nel privato esprime solamente una piccolissima frazione di realtà. Quando viene presentata nel suo contesto, nei tempi nei quali uno vive, la realtà diventa più simile ad un prisma. E a questo punto che ci imbattiamo in una delle pietre miliari del cinema di Jarl: il montaggio.
Jarl sostiene che certe cose sono troppo irrilevanti perché un film le descriva, mentre abbiamo visto altre cose così spesso che siamo diventati ciechi. Ancora una volta la realtà deve essere resa visibile. Per esempio, un'immagine può non avere alcun valore quando è l'ultima in una sequenza di tre, ma quando viene posta tra le altre due, appare qualcosa che non avevamo visto prima. Con l'aiuto del montaggio, possiamo far sì che il tempo sia immobile, lasciare che le cose si strappino, drammatizzare la realtà e così rendere visibile l'invisibile. E avvicinarci alla verità.
Per me, uno dei migliori esempi di montaggio nei film di Stefan Jarl sono i primi diciotto minuti di Naturens hämnd (La vendetta della natura, 1983). Durante quei minuti, semplicemente grazie al montaggio, veniamo introdotti nei tre livelli del film e già all'inizio ci rendiamo conto, in modo terribile, del perché il piccolo Peter pianga.
Ma naturalmente uno pensa anche alla sequenza del "paradiso delle comodità” in Una vita rispettabile, dove passiamo dal totale squallore degli emarginati alle lunghe dita delle signore della buona società al mercato alla moda ad Östermalm. II montaggio rivela un legame, una verità: la società dei consumi è svelata.
In maniera più sottile, in Il tempo non ha nome, dai passi stanchi e dal faticare dell'ultimo contadino, passiamo alla foca morta sulla scogliera. Questo sta succedendo proprio adesso, in questo momento. I due insieme vogliono dire qualcosa circa i tempi in cui viviamo. Nuovi legami, nuove verità. La realtà complessa è resa visibile.
È in questa instancabile caccia alla verità che credo che i film di Jarl mi raggiungano e mi tocchino. Devo confessare che sento la più grande ammirazione e rispetto per questa passione, questa resistenza che Jarl instancabilmente porta con sé dopo tutti questi anni. Ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è scritto da qualche parte sulle Tavole di pietra di Mosé, quella è la principale forza motrice nella cinematografia di Jarl. Ricordo che una volta, mentre stavo intervistando Bo Widerberg (un'altra divinità di Jarl), gli chiesi cosa significasse per lui l'abusata parola "moralità". Subito, senza traccia di esitazione o dubbio, egli rispose: "Tutto. È l'inizio e la fine". Per lui, la moralità significava rispetto per la vita, non far male a nessuno.
La moralità è quasi sinonimo dei film di Jarl. Essi nascono da una profonda compassione per la vita che è stata violata, sia questa un tossico che si infila il suo ultimo ago in una vena, un bambino di due anni malato di cancro, un lago avvelenato, i sami che improvvisamente scoprono la pioggia radioattiva di Cernobyl che si posa tutt'intorno a loro o un contadino solitario il cui stile di vita sta scomparendo. Con autoironia e nello stesso tempo con serietà, Jarl di solito semplifica tutto dicendo: "Tutti i miei film parlano della stessa cosa, sono tutti film di compassione".
Nel suo film incompiuto Förwandla Sverige (Cambiare la Svezia, 1966-74), Jarl porta la sua critica alla civiltà al suo punto massimo e dice: "Siamo occupati da una potenza straniera". È tornato all'idea di società come prigione in tutti i suoi film seguenti, ma probabilmente mai in maniera così definitiva, cupa e rassegnata come in Cambiare la Svezia. Anche ne La vendetta della natura, quell'analisi intensamente cupa del ruolo che l'umanità si è autoassegnata di "giardiniere della natura", riusciamo ad intravedere un raggio di luce.
Questa compassione è l'impulso prominente che "protegge" i film di Jarl. È ciò che determina che un film completamente impossibile dal punto di vista commerciale, come Il tempo non ha nome possa nascere, ed è ciò che lo motiva a finire, praticamente senza un soldo, un ritratto di 35 minuti di un ragazzino sami di 12 anni nel suo cortometraggio Jåvna – Renskötare år 2000 (Jåvna - Pastore di renne nel 2000, 1991).
L'atto di finire questi film è anche un mezzo di riconoscimento, piuttosto che di soppressione, di questo impulso. Il senso di compassione è tenuto in vita. Ma Jarl sottolinea anche l'importanza di non confondere mai il successo immediato e quantificabile di un'opera d'arte con quello che è molto più vitale: il suo valore nel tempo. L'arte è eterna e forse nel 2050 qualcuno vedrà La minaccia e penserà: "Allora è così che i sami e la loro cultura sono stati cancellati!", oppure considerate il valore di Il tempo non ha nome quando non ci sarà più l'ultimo contadino.
In questo contesto è naturale considerare un'altra delle maggiori fonti di ispirazione di Jarl, il pittore Pieter Bruegel: "Ho sempre voluto che i miei film avessero lo stesso effetto dei suoi quadri. Egli riuscì a fare della grande arte dai suoi commenti allegorici sulla vita contemporanea. lo posso stare seduto a lungo a guardare i suoi quadri. Senza Bruegel non sapremmo tutto quello che sappiamo sulla vita nel sedicesimo secolo".
Spero che un giorno o l'altro in futuro, potremo guardare indietro al cinema di Robert Flaherty, Joris Ivens, Santiago Alvarez, Arne Sucksdorff, Peter Weiss, Eri M. Nilsson e Stefan Jarl (per collocarlo all'interno di una tradizione e di un contesto) e vedere immagini che ci offrono una grande conoscenza del nostro breve periodo sulla terra durante l'ultima metà del ventesimo secolo. Sono assolutamente convinto che i film di Stefan Jarl, non solo da un punto di vista sociologico, ma anche antropologico ed ecologico, saranno allora testimonianza indispensabile ed un contributo vitale al lavoro di ricerca del futuro.
(Mats Nilsson, Stefan Jarl - Partisan and Poet, The Swedish Institutet, Stoccolma 1991)
«È stato assolutamente logico per Stefan Jarl fare il lungometraggio a soggetto La gente buona dopo Il tempo non ha nome, perché in questo inno sacro di un'ora per l'ultimo agricoltore e la sua uscita dalla storia, egli ha veramente raggiunto i limiti di ciò che è possibile fare con un documentario. Se un documentario può a ragione essere definito un'opera d'arte, e così definendolo si desidera tracciare un parallelismo con le arti visive, allora Jarl è andato fin dove si può andare per quanto riguarda Il tempo non ha nome. La lunga inquadratura della fattoria del vecchio, pochi minuti nel film, non è niente meno che il vecchio Rembrandt trasposto sullo schermo. Le lunghe inquadrature nel film e l'ovvia riluttanza a tagliare una nuova immagine troppo spesso, si basano sulla positiva caparbietà di Jarl. In numerose occasioni e con grande fervore, egli si è riferito ad un incontro che ebbe con il documentarista britannico Peter Watkins (The War Game). Quest'ultimo disse a Jarl che i risultati di uno studio (che lui stesso aveva condotto), mostravano che nessuna inquadratura alla televisione americana durava più di sette secondi. Questa notizia stimolò l'immaginazione di Jarl: ovviamente egli non avrebbe fatto un film nel quale ci fosse una sola inquadratura sotto i sette secondi!
Inizialmente Jarl pensava ad un cortometraggio la cui durata sarebbe stata approssimativamente di 15 minuti. Ma mentre stava filmando capì che quello che si stava aprendo davanti ai suoi occhi era un gigantesco dramma contemporaneo. Allo stesso tempo iniziò a comparire un grande dubbio: drammi come questo avvengono dovunque mille volte al giorno. Perché lui avrebbe dovuto filmare questo?
Filmando sporadicamente la vecchia coppia, Teodor e Asta Svensson, da circa un anno, iniziò a crescere l'idea di dipingere il tempo nel film. Era qualcosa che lo interessava già da molto tempo. Capì che, dato il suo materiale, avrebbe potuto ritrarre sia il tempo esterno, il tempo oggettivo che si può vedere sull'orologio, e metterlo in contrasto con il tempo interno che ha il suo proprio orologio, e che talvolta si ferma completamente. In tutti i suoi film Jarl ha consciamente cercato di conseguire una dialettica. Tutto è visto con più chiarezza quando viene illuminato dal suo opposto. Il tempo non ha nome è completamente basato su un metodo dialettico. L'alba è seguita dalla notte, la primavera dall'inverno, la luce dal buio e la vita dalla morte.
Il film si apre con il sorgere del sole che dura quasi cinque minuti. Le onde si infrangono ritmicamente sulla spiaggia, tutto è calmo. La musica di Ulf Dageby cresce: meditativa, calma, intima e in qualche modo elegiaca. Puri suoni classici che ci portano ad uno stato di riposo e ci cullano nella cadenza della narrativa del film. Questa è la nascita della creazione. Nella scena finale del film il mare è di nuovo lì, ma questa volta è notte. L'acqua è nera e invisibile finché il vicino faro getta il suo raggio di luce sulle profondità nere e gonfie. L'apocalisse non è imminente ma ci sentiamo avvertiti, minacciati.
Anche il vecchio agricoltore si consuma lentamente durante il corso del film. In una scena verso la fine lo vediamo nel granaio. La pallida luce invernale lo fa apparire quasi trasparente mentre il vento di una tempesta di neve che si sta preparando ulula all'esterno. Poche scene prima avevamo visto un'automobile andare verso la chiesa del paese, così che improvvisamente non siamo più sicuri...
È affascinante vedere come i metodi limitati ma tuttavia sottili di Stefan Jarl riescano a drammatizzare e disturbare questo mondo, che alla superficie sembra completamente immobile. Con la poesia delle sue immagini e la magia del montaggio riesce perfino a farci dubitare che l'agricoltore sia ancora con noi.
I critici di Jarl hanno suggerito che in Il tempo non ha nome egli favorisca un ritorno all'aratro di legno (la stessa critica gli era stata mossa per La vendetta della natura). Io ritengo che sia un modo molto superficiale di guardare al film. Jarl stesso sottolinea l'importanza di conoscere bene la propria identità nazionale e culturale. Il tempo non ha nome indica che la pianta ha perso il contatto con le sue radici, che c'è una mancanza di comprensione e di relazione. II sottotitolo ironico del film "Un contributo alla ricerca antropologica", rivela che è così.
Jarl parla anche della memoria collettiva, che abbiamo in comune più di quanto immaginiamo con coloro i quali sono già sepolti. Naturalmente egli vede l'agricoltore nel film come un esponente e un portatore della memoria collettiva, uno degli ultimi della sua razza, uno che sta uscendo dalla vita contemporanea.
Il tempo non ha nome è, come i primi film di Jarl, un film di resistenza. Ma questa volta i movimenti sono meno ampi, il tono non così tumultuoso. Egli osserva la grande prospettiva partendo da un piccolo angolo della realtà». (M. Nilsson)
Mats Nilsson è critico cinematografico e autore del libro Rebell i vekligheten - Stefan Jarl och hans filmer (Ribelle nella realtà - Stefan Jarl e i suoi film), Filmkonst n. 7/Filmbiblioteket n. 1, 1991.
Esplora per area tematica
Vedi tutti i film