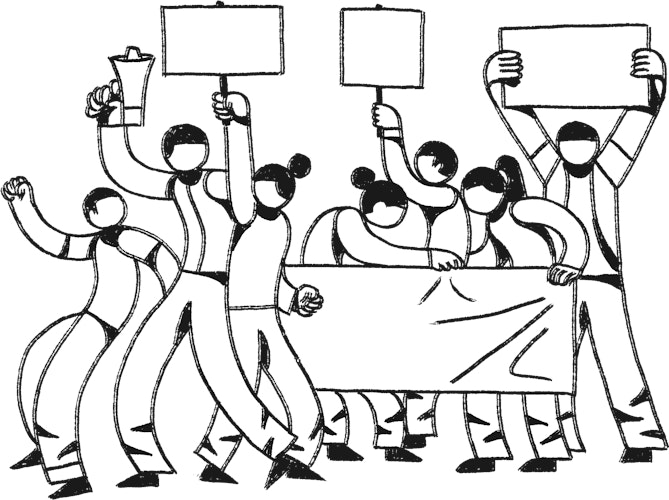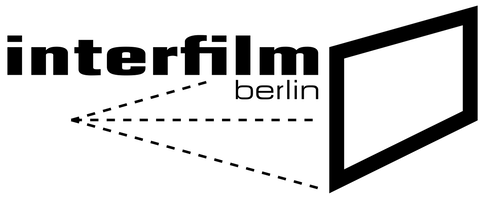The Corporation
Diretto da
Al giorno d'oggi le multinazionali ricoprono un ruolo in precedenza appannaggio della Chiesa o della Monarchia: rappresentano l'istituzione dominante che, più di ogni altra, determina il modo in cui viviamo, sulla quale non abbiamo alcun controllo anche se da un punto di vista legale hanno lo stesso statuto giuridico di una persona. Ma quale persona pone il profitto davanti a tutto, senza alcuna preoccupazione? Inquinamento, condizioni di lavoro disumane, frodi e violazioni delle più elementari norme etiche sono la pratica quotidiana all'interno delle politiche economiche di questi giganti del commercio, capaci di influenzare pesantemente la vita politica di ogni paese. Uno sguardo lucido e disincantato in un film vibrante di denuncia e sdegno di fronte ai crimini impuniti di questi moderni padroni.
Approfondimento
A proposito di The Corporation
Panaria Film. Avventura e poesia nel cinema italiano di Alessandro Giorgio
Vi sono episodi e personaggi nella storia del cinema italiano che non hanno avuto spazi e riconoscimenti all'altezza della loro concreta importanza. È a tutti noto che il primo decennio dopo la guerra è stato tra i momenti più ricchi e fortunati del nostro cinema, segnando una pagina fondamentale per il rinnovamento della cinematografia europea e non solo. Resta quindi comprensibile il fatto che qualcosa o qualcuno sia stato ridimensionato. La storia di una “piccola” casa di produzione, attiva tra il 1946 e il 1955, di origine tutta siciliana che prende il nome da una delle più lontane delle isole Eolie, può servirci a comprendere la ricchezza di quegli anni e il ruolo avuto da autentici pionieri, capaci di rischiare con produzioni azzardate che hanno consegnato alle storie del cinema momenti e opere fondamentali, tali da influenzare anche grandi registi e attori. La Panaria Film nasce quasi per gioco. Dietro questo nome ci sono Francesco Alliata di Villafranca, Quintino di Napoli, Pietro Moncada di Paterno, Renzo Avanzo (cugino di Rossellini e marito di Uberta Visconti, sorella di Luchino). A questi va aggiunto il lavoro straordinario di Fosco Maraini, le cui fotografie segnano un contrappunto lucido e meraviglioso fatto di volti e situazioni di una Sicilia oggi scomparsa.
«Tutto cominciò in quel 1946 quando noi, freschi reduci della guerra assassina, felici di essere sopravvissuti e ansiosi di rifarci nel "bello" e nel sano della tragedia vissuta in quegli anni, ci trovammo con il desiderio comune di scoprire e raccontare il mare attraverso il cinema e la pesca subacquea». Le parole di Francesco Alliata, oggi ultimo depositario delle memorie del tempo e detentore di un archivio di notevole valore e interesse, lasciano ben intendere lo spirito con cui iniziò quella che fu una vera e propria avventura. Personaggio nato con il cinema nel sangue, addestratosi, da universitario, nei Cineguf di Palermo e Napoli, cineoperatore durante la seconda guerra mondiale per l'esercito e per il Luce, si adoperò incessantemente in una miriade di attività che andavano ben oltre la figura del produttore-contabile. Ancora oggi non vi sono controprove all'affermazione che le immagini dei primi documentari della Panaria siano state l'origine del cinema subacqueo mondiale. Qualcosa di più di un semplice esperimento. L'iniziativa di Francesco Alliata ha dato alla luce innanzitutto un gioiello di artigianato cinematografico: la custodia dell'Arriflex 35mm con cui sono state girate differenti scene sottomarine. Così l'interesse principale del gruppo si orienta verso prove e tentativi di miglioramento delle strumentazioni, per l'idea inizialmente generica di mostrare il paradiso delle Eolie, ai tempi poco noto, dotato di un'aura primitiva e velata di mistero. Questa genericità invece trova quasi immediatamente una sintesi e una forma che assicurano, con stupore degli stessi autori, la realizzazione di documentari di un equilibrio autoritario il cui valore non dipende esclusivamente dalla novità e spettacolarità delle immagini subacquee. Si tratta di Cacciatori sottomarini (1946), Tonnara, Bianche Eolie, Isole di Cenere tutti del 1947 seguiti da Opera dei pupi e Tra Scilla e Cariddi, girati l'anno successivo con la macchina da presa guidata da quelli che di lì a poco i giornali battezzeranno come “i ragazzi della Panaria”. Dotato anche di una sana predisposizione a rischi effettivi, coraggio e un po' d'incoscienza, Alliata con Tonnara “battezza” l'Arriflex rivestita, nella “camera della morte”, in compagnia di centinaia di tonni agitati. Non sarà l'unico momento in cui il nostro protagonista si cimenta in pericolose operazioni, per le sequenze sottomarine di Vulcano, ad esempio, la sua vita era legata a un tubo di caucciù e alle mani di Federico Kechler che dalla barca regolava la pressione dell'aria. Piccoli episodi che ci aiutano a inquadrare la figura fuori dagli schemi di questo produttore, regista e operatore, capace di spaziare dalla quadratura dei conti, all'artigianato cinematografico, passando per i panni di uno spericolato pioniere.
I meriti di questi lavori, oltre alla dimensione pionieristica, sono anche antropologici e cinematografici. La documentazione di pratiche di tradizioni perdute della Sicilia, ben otto anni prima degli esordi alla regia di Vittorio De Seta che proprio con la Panaria mosse i primi passi, si associano a una parallela ricerca di organicità nel lavoro sull'inquadratura e sul montaggio. I puntuali successi ai festival internazionali e l'ottima accoglienza della stampa danno la possibilità al gruppo, «Quattro siciliani cantori cinematografici» come titola un articolo di Giovanni Schisano del 1949, di pensare al cinema in grande. Inoltre grazie alla legislatura, notoriamente raggirata dagli esercenti, legata alla proiezione dei documentari in sala, anche il pubblico dell'epoca ebbe la possibilità di apprezzare questi lavori.
Il giá famoso regista Roberto Rossellini che, coinvolto dal cugino Renzo della Panaria, aveva dato loro una mano a Roma per la post-produzione dei documentari, si appassionò al mondo delle Eolie, così arcaico e genuino; tanto da immaginare con i "ragazzi" la realizzazione di un film in quei luoghi, da predisporre su misura per l'interpretazione di Anna Magnani, sua partner di lavoro e di vita. A preparazione ormai avanzata (si erano già reperiti i fondi, firmati i contratti di coproduzione e distribuzione con la Artisti Associati italiana e la United Artists americana, giunti a buon punto nella stesura della sceneggiatura), improvvisamente Rossellini sparì dalla scena. La situazione che si venne a creare rappresentò uno dei momenti di cronaca cinematografica, rigorosamente tinta di un rosa che ancora non sbiadisce: la storia è quella che segue la fuga di Rossellini dalla Magnani, la conquista di Ingrid Bergman e la tumultuosa separazione dal marito svedese Peter Lindstrom, e la realizzazione sovrapposta di due film nelle Eolie.
Su di un'isola la Panaria con William Dieterle, Geraldine Brooks, Rossano Brazzi e Anna Magnani realizzava Vulcano, mentre con i soldi recuperati dall'attrice svedese persuadendo Howard Hughes, Rossellini e la Bergman lavoravano a Stromboli, terra di Dio. La storia di queste due produzioni, lunga, tumultuosa ed estremamente appassionante, è raccontata con perizia e gusto dall'ottima monografia di Alberto Anile e Gabriella Giannice completamente dedicata a La guerra dei vulcani come appunto titola. Le difficoltà climatiche e logistiche non impedirono ad Anna Magnani di regalare di sé una prova straordinaria. Altro merito della Panaria è infatti quello di aver dato la possibilità alla più grande attrice del nostro cinema di consolidare quel “mito” che si stava creando intorno alla sua figura con due film molto differenti: la tragicità e la tensione del personaggio di Maddalena da un lato e l'esuberanza incontenibile della Camilla de La carrozza d'oro quattro anni dopo. Jean Renoir definì “sconvolgente” la prestazione della Magnani nel film da lui diretto. Anche la storia di questa produzione di Alliata, nella sua complessità, nelle incertezze, nella determinazione con cui si era arrivati al primo sudato ciak, dimostra la vitalità del marchio della Panaria, malgrado che il tipo di film in sé si discosti molto dalle peculiarità dei lavori fino a qui portati a termine. Questa volta niente mare e condizioni naturali complicate, ma rimane intatto quello spirito di sperimentazione che ha contraddistinto i dieci anni di attività della casa di produzione. Francesco Alliata con La carrozza d'oro è andato molto vicino anche a un altro primato, quello di essere il primo a produrre in Italia un film a colori, primato che di poco spetta invece al Ferraniacolor di Totò a colori di Steno, precedente al lavoro di Renoir che resta comunque il primo Technicolor del cinema italiano. Il film fu inizialmente commissionato a Luchino Visconti che per troppi mesi gettò al vento le risorse finanziarie della Panaria. A un definitivo chiarimento con Alliata, che dovette subire ingiustamente il rifiuto del gotha del cinema italiano dell'epoca perché “uno come Visconti non si può protestare (ovvero licenziare)”, segue l'allontanamento del regista. Tutto sommato, malgrado l'aggravio economico, fu un fatto provvidenziale che spinse il produttore a ingaggiare subito dopo l'entusiasta Jean Renoir, che di Visconti era stato il maestro. Dal punto di vista "industriale" questa produzione è da ricordarsi per aver realizzato nei medesimi imponenti e costosi set costruiti a Cinecittà ben due altri film in contemporanea a La carrozza d'oro, ció per aumentare le possibilità di recupero degli sperperi iniziali. Risultò una fortunata acrobazia finanziario-organizzativa, unica nella storia del cinema.
Torniamo al mare. Sull'idea di esplorarlo per individuarvi nuove risorse da offrire all'uomo, nasce il lungometraggio documentario dal significativo titolo: Sesto Continente. Per la prima volta il colore appare in riprese subacquee con un altro sforzo produttivo acrobatico che coinvolse tre continenti: Africa, Europa e America. Alliata inoltre vi fa esordire alla regia un promettente allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia dal nome di Folco Quilici.
Insieme a questi film è da ricordare la storia dei documentari che li aveva preceduti e accompagnati, contribuendo a far conoscere al mondo le isole Eolie e gli aspetti più peculiari della Sicilia, la sua cultura, le sue tradizioni. Come fu per la successiva produzione della Panaria, Village magique (Vacanze d'amore, 1954) di Jean-Paul le Chanois, ambientato a Cefalù nel primo "villaggio vacanze" italiano, con Vittorio De Seta alla sua prima esperienza come assistente alla regia. Lungometraggio girato in Ferraniacolor che segna l'esordio di Domenico Modugno e della sua chitarra.
Seguì Agguato sul Mare, forse il primo film italiano in Cinemascope (1955), in cui lo schermo gigante fu utilizzato per esaltare la terra di Sicilia con le indimenticabili prime immagini aeree dei suoi luoghi mitici.
Questa breve introduzione vuole rendere omaggio ai pionieri della Panaria Film, sperando che questo nome venga ricordato adesso che, dopo oltre cinquant'anni, la loro avventura è tornata ad essere protagonista di numerose retrospettive, festival e incontri non solo in Italia: quasi come un Grand Tour, questa volta cinematografico, che oggi fa riscoprire la Sicilia. Speriamo che la retrospettiva-omaggio di Cinemambiente dedicata alla Panaria, contribuisca a riaccendere nuovi interessi, che possano ridare visibilità a questi film e memoria a un'avventura breve, ma eccezionalmente intensa.
Attivismo
Esplora per area tematica
Vedi tutti i film