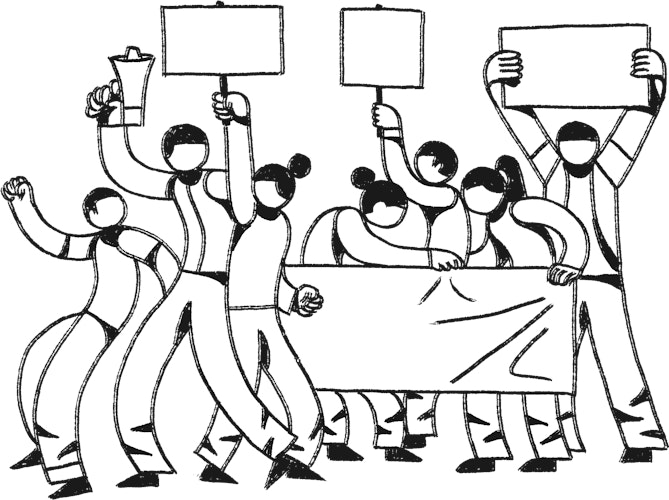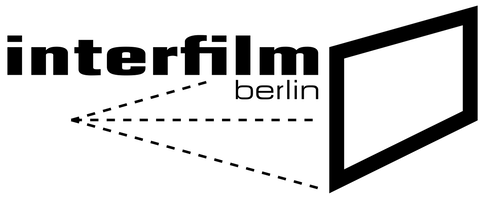Breaking the Bank
Diretto da
Realizzato durante le manifestazioni di protesta tenutosi a Washington in occasione del vertice annuale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e Banca Mondiale (BM), con modalità produttive e distributive analoghe a quelle di Showdown in Seattle, ma con un taglio più analitico. Attraverso un sapiente lavoro di montaggio, le voci dei partecipanti vengono cucite assieme per offrire un'approfondita analisi di come FMI e BM, di concerto con l'OMC, promuovano deliberatamente lo sfruttamento e l'impoverimento umano e ambientale nei paesi sottosviluppati, di come esse sostengano le dittature e contribuiscano alla diffusione di conflitti armati. Il racconto di un indio del Guatemala, venuto a Washington a testimoniare lo sterminio del proprio villaggio, colpevole di intralciare la realizzazione di un progetto finanziato dalla BM, è uno dei momenti più toccanti. Vengono illustrati inoltre oltre l'addestramento dei partecipanti alle tecniche di resistenza non violenta, nonché agli abusi e alla brutalità della polizia.
Approfondimento
A proposito di Breaking the Bank
«“Affinché la globalizzazione funzioni, l'America non deve aver paura di agire da superpotenza onnipotente qual essa è la mano nascosta del mercato non funzionerà mai senza un pugno nascosto. McDonald's non può fiorire senza McDonald Douglas, il progettista degli F-15, e il pugno nascosto che rende il mondo sicuro per la tecnologia di Silicon Valley si chiama Esercito degli Stati Uniti”. (T. Friedman, New York Times, 28.3.1999)
“Sono sotto costante controllo video. Questo è il mantra che le forze dell'ordine a Bologna per il vertice OCSE devono ripetere, Si ricordino che sono sotto il controllo video di circa 40 video operatori indipendenti. Webcam sono state piazzate alle finestre dei palazzi. Ogni operatore è a sua volta filmato da un altro operatore a distanza. Fare informazione e filmare è un diritto di tutti. Nessun articolo di legge può impedirlo”. (Comunicato di un gruppo di videomaker sul sito dell'Independent Media Center italiano, giugno 2000)
Uno degli indubbi meriti della rivolta di Seattle è stato il portare i movimenti ecologisti a una maggiore presa di coscienza di quella sempre più stretta dipendenza esistente fra politica ambientale e politica commerciale ed estera, come sottolineato dal presidente della Commissione Ambiente del Senato, Fausto Giovanelli, nella sua prefazione alla recente traduzione italiana del rapporto su ambiente e globalizzazione curato dal World Watch Institute. Al centro della manifestazione che ha portato a sfilare finalmente uniti “camionisti e tartarughe”, ritroviamo non a caso tutti e tre gli elementi nominati nella brutale ma veritiera descrizione della globalizzazione citata di Thomas Friedman, considerato uno dei suoi più prestigiosi alfieri: McDonald's, assunto a simbolo del “malmangiare globale”; il suo pugno nascosto, qui manifestatosi in una delle più violente repressioni poliziesche attuate negli Stati Uniti contro un'espressione di dissenso dei suoi cittadini dagli anni Sessanta a oggi; infine il gioiello di Silicon Valley, Internet, trasformato in uno degli strumenti chiave della protesta globale. È tramite Internet, infatti, che le varie organizzazione non governative confluite a Seattle hanno potuto coordinare le loro iniziative, qui e negli appuntamenti successivi durante i quali hanno continuato a denunciare i sacrifici umani e le catastrofi ambientali determinati dalle politiche dei grandi globalizzatori. Una delle reti nata a Seattle e propagatasi sulla sua onda è quella degli Independent Media Center (IMC), che nelle varie città dove sono sorti hanno coordinato il lavoro dei giornalisti indipendenti e diffuso attraverso i loro siti web (http://www.indymedia.org) le immagini e le informazioni raccolte. Si tratta di un lavoro di controinformazione e cinema militante, realizzato cioè da persone direttamente coinvolte nelle proteste e finalizzato alla loro riuscita e diffusione. Un lavoro che per un verso assume forme originali ed estremamente efficaci, perfettamente adeguate a un movimento che ha il suo punto di forza proprio nella connessione fra diverse organizzazioni. Per l'altro raccoglie una ricca quanto poco nota eredità, nel cui contesto è importante collocare l'attività degli IMC. In primo luogo il lavoro svolto nei due decenni precedenti dai molti collettivi video che negli Stati Uniti hanno usato gli spazi della televisione via cavo per un cinema comunitario e socialmente impegnato. Alcuni di questi gruppi, come Piper Tiger TV, sono stati direttamente coinvolti nella formazione dei primi IMC e nella distribuzione dei video da loro prodotti. Si tratta di collettivi che a loro volta proseguivano l'attività dei gruppi di filmmaker sorti in tutto il mondo durante le rivolte degli anni Sessanta: i diversi collettivi di “Newsreels” statunitensi che documentavano e sostenevano le lotte degli studenti, del Black Panther, dell'emancipazione femminile e dei partiti politici della nuova sinistra; dei collettivi di cinema militante sorti in Europa, soprattutto in Francia, Italia e Germania, che portavano le cineprese nelle fabbriche; di quelli infine dei paesi dell'America Latina, come i cinegiornali proiettati dai “cinemobili” cubani o i “communicados” messicani. Un cinema che veniva realizzato, presentato e discusso nei luoghi dove avvenivano le lotte, meglio se direttamente da chi le faceva: gli operai della Manuli Brugherio che occupano la fabbrica subito dopo che vi è stato proiettato un film (Apollon, 1969) con cui altri operai documentavano l’occupazione della loro fabbrica, è un esempio che può chiarire l’ideale di un cinema concepito innanzitutto come strumento di lotta. Altrettanto importante è il suo voler essere una forma di comunicazione “da molti a molti” opposto a quella “da uno a molti” rappresentata dal cinema ufficiale e dalla televisione, secondo una formula coniata da Brecht per la radio e fatta propria ad esempio da Zavattini nei bollettini in cui descrive i suoi “Cinegiornali liberi” del 1968. Se alla luce degli intenti formulati in quegli scritti, esemplari delle generali aspirazioni dell'epoca, si esamina la rete degli IMC, non si può che restare colpiti da come questa sembri rappresentare oggi lo strumento tecnico e il modello organizzativo ottimale per la realizzazione di quegli intenti. Una struttura che permette la circolazione di immagini accompagnate da informazioni e analisi approfondite; che al pari della televisione offre un flusso di informazioni costantemente aggiornato, ma a differenza di questa consente, attraverso la navigazione negli archivi che essa via via costruisce, anche l'elaborazione di una memoria critica; che è aperta al contributo di tutti, ma consapevole della necessità di una politica redazionale che viene collettivamente e trasparentemente elaborata; che permette il dibattito fra i singoli e i diversi gruppi accomunati dal desiderio di informazione e di trasformazione della realtà. L'aspetto tecnico va sottolineato, ma non sopravvalutato a scapito delle diverse forme sociali (modalità produttive, distributive e di fruizione) che costituiscono parte integrante di un cinema politicamente considerato. Certamente il cinema militante degli anni Sessanta è stato reso possibile dalla cinepresa portatile in 16mm che consentiva la presa diretta del sonoro, offrendo una maggiore flessibilità e minori costi rispetto al 35mm, anche se in alcuni degli esempi citati si è continuato ad utilizzare il 35mm (Cuba) o l'ancora più economico super8 (in Messico e a volte anche in Europa). Il video ha rappresentato un ulteriore passo avanti in questa direzione, tanto che nel 1968 Godard commentò proprio in tal senso la sua comparsa sul mercato: “Chiunque potrà fare un telegiornale da sé. E' questo l'importante”. D'altra parte il progresso tecnico non è di per sé garante di forme di comunicazione democratiche, come provano ad esempio le tante trasmissioni di televisione-spazzatura realizzate sfruttando la tanto auspicata diffusione di videocamere a basso costo. L'ultimo esempio di questo aneddotico percorso a ritroso nella storia di un cinema autenticamente politico è la rete di cineclub della Workers Film and Photo League, nata utilizzando addirittura una tecnologia appena resa obsoleta e pertanto economicamente accessibile come era il cinema muto all'avvento del sonoro. Negli Stati Uniti devastati dalla Grande Depressione, mentre il circuito monopolizzato delle sale cinematografiche bandiva dai cinegiornali ogni minimo accenno al dramma in corso, queste associazioni di registi, sorte in diverse città e collegate a gruppi affini in Europa, documentavano le “marce della fame” e le proteste dei disoccupati con i loro film realizzati e presentati in luoghi e forme alternativi. Molti di questi registi appoggiarono in seguito le riforme agrarie del “new deal”, realizzando tra l'altro alcuni dei primi film che denunciavano i guasti ambientali causati da una politica sregolata. Questo pochi anni prima che alle opere pubbliche venisse preferita una nuova guerra come soluzione ai guasti di un capitalismo ben avviato sulla strada di quella globalizzazione, che allora si chiamava imperialismo, e venisse così messa a tacere per un pezzo, negli Stati Uniti come in Europa, ogni espressione di cinema indipendente».
(Marco Farano)
Attivismo
Esplora per area tematica
Vedi tutti i film