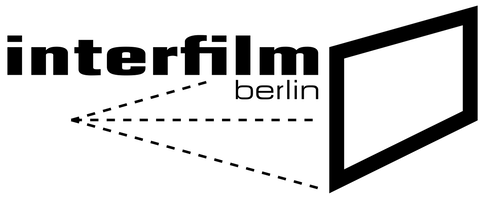Uomini e lupi
Diretto da
Il paesino di Vischio, sulle pendici dell'Appennino abruzzese, come ogni inverno è assediato dai lupi che calano a branchi minacciando gli ovili. Per tutelare le greggi, si promettono dunque ventimila lire per ogni belva uccisa e la ricompensa attira in paese due "lupari": Giovanni, forte di una lunga esperienza, che giunge a Vischio con la moglie Teresa e il figlio Pasqualino, e Ricuccio, imbattibile a parole, ma in realtà più dotato per la caccia alle belle ragazze che ai lupi feroci. Assunto da Don Pietro, ricco possidente, per mettere le tagliole nelle sue campagne, Ricuccio comincia subito a corteggiarne la figlia Bianca, mentre si sviluppa una forte rivalità tra lui e Giovanni. Dopo un inizio sfortunato, Giovanni, dal canto suo, riesce a intrappolare una lupa: vorrebbe prenderla viva, per ottenere la cospicua ricompensa promessa da un giardino zoologico. Ma gli ululati della belva intrappolata richiamano l'intero branco e Giovanni perde la vita. Ricuccio, colpito dalla tragica fine del rivale, si lancia alla caccia dei lupi, ne uccide uno, lo porta a Teresa e accompagna la moglie e il figlio del rivale morto per tutti i paesi vicini (la tradizione vuole infatti che, dopo la cattura di un lupo, il luparo giri nei paesi circostanti per raccogliere i doni degli abitanti riconoscenti). Tornato a Vischio, Ricuccio si prepara a scappare con Bianca, divenuta la sua amante. Don Pietro, venuto a conoscenza del progetto, vuole vendicare l'onore della figlia, ma l'accorato intervento di Teresa lo convince a dare il suo consenso al matrimonio. L'inverno è ormai finito, Teresa lascia il paese. Ma all'ultimo momento Ricuccio, inutilmente inseguito da Don Pietro, la raggiunge: ha infatti capito di amarla e di voler vivere con lei e con il piccolo Pasqualino.
Per le riprese del film, realizzate nel Parco Nazionale d'Abruzzo, vennero importati numerosi lupi dalla Siberia, che successivamente morirono, anche se affidati alle cure di Angelo Lombardi, il futuro conduttore della nota trasmissione "L'amico degli animali".
Caro Aristarco, sta per uscire Uomini e lupi, un film che nei titoli di testa e in tutta la pubblicità, le case produttrici associate Titanus-Trionfalcine, presentano con la mia firma. Ritengo mio dovere portare a conoscenza che, in realtà, l'edizione del film che andrà in visione è stata in tutto approntata e curata dalla Titanus, per mano di tecnici che neppure conosco, e non già da me personalmente, come invece la presenza del mio nome nel film fa supporre. [...] La Titanus – anche se divisa in questo dalla sua associata Trionfalcine – mi chiese, prima di lasciarmi procedere al doppiaggio, di ridurre la lunghezza del film a un metraggio di 2.800 metri, sostenendo che il mio montaggio risultava in molte parti lento e anti-spettacolare. Mi rifiutai di eseguire i tagli richiesti, avendo, tra l'altro, per raggiungere il metraggio di 3.300 metri, sacrificato già alcune importanti scene del film. [...] Le mie buone ragioni, purtroppo, non valsero a persuadere la Titanus che volle a ogni costo ridurre il metraggio, trincerandosi dietro una clausola del mio contratto di regia, per la quale ero obbligato a rispettare quest'ultima lunghezza. Decisi, allora, di abbandonare il lavoro del film, amichevolmente e in buon accordo con la Titanus, ritenendomi sinceramente incapace di apportare qualsiasi altro taglio alla mia versione, non volendo – attraverso una inevitabile lunga polemica, privata o giudiziaria – provocare ritardi all'uscita del film, cosciente del grande sforzo economico dai produttori affrontato, e tenendo conto, soprattutto, della grave situazione in cui versa attualmente il nostro cinema.
È avvenuto così che il montaggio definitivo di Uomini e lupi, il suo doppiaggio, la musica e il "mixage", sono stati curati completamente al di fuori della mia diretta – o indiretta – responsabilità. Pertanto non conosco l'edizione del film così come sarà programmato. Mi auguro, tuttavia, che il lavoro dei tecnici che mi hanno sostituito sia migliore del mio, e che il film possa avere un buon successo. In ogni caso i meriti, o i demeriti, non saranno del tutto miei.
(Giuseppe De Santis, "Cinema Nuovo", n. 100, 15 febbraio 1957, in Rosso fuoco. II cinema di Giuseppe De Santis, a cura di Sergio Toffetti, Lindau, Torino 1997, p. 397)
Approfondimento
A proposito di The Wolves
«Che De Santis abbia le sue buone ragioni per lamentarsi, è cosa che non mettiamo in dubbio. Ma che De Santis sovente agisca d'impulso, è un fatto a noi ormai familiare. [...] Di tutti i registi italiani del dopoguerra De Santis è sicuramente il più ostinato, il più cocciuto nella fedeltà ai propri temi. [...] I suoi soggetti non suggeriscono conflitti, lotte di classe: li impongono addirittura come fatti inevitabili, come unica ragione di vita per il cinema. II suo messaggio è schietto, non ne dubitiamo, ma è anche di una semplicità che rasenta i confini dell'ingenuità. E tuttavia, proprio in questa testardaggine, vediamo i notevolissimi pregi e i non indifferenti difetti di un regista che merita molta più attenzione di quanta non gliene venga oggi accordata.
Dopo aver visto Uomini e lupi nell'unica edizione possibile, ossia con i tagli lamentati dal regista, l'opinione che il miglior De Santis, i più genuino, sia proprio quello dei film senza soverchie preoccupazioni polemiche, si rafforza. E al tempo stesso si fa largo una curiosa convinzione: che i tagli inflitti dai produttori al film, per alleggerirlo in vista delle esigenze commerciali, siano stati estremamente salutari. Per parlare con piena coscienza avremmo dovuto vedere il film intero, ci dirà De Santis. È probabile. Ma è probabile, d'altra parte, che il raffronto non possa persuaderci del tutto. Quando sullo schermo, una settimana fa, è apparso il "prossimamente" di Uomini e lupi, quei pochi metri di pellicola contenevano esattamente tutto quello che De Santis per anni ha stipato nei film, alla nausea, tutte le predilezioni folcloristiche del regista ciociaro, tutti i punti deboli di quest'uomo di cinema che per altri versi merita attenzione e grande considerazione. [...] Orbene, nell'edizione definitiva di Uomini e lupi, il sovraccarico è scomparso. Il film s'è ridotto alla storia pura e semplice di due lupari, capitati a Vischio, sui monti della Marsica, in Abruzzo, per dare la caccia alle terribili bestie che d'inverno scendono a valle per cercare il cibo. [...] Per il resto, la trama offre storie d'amore e di caccia; momenti di alta e ben dosata tensione; attimi di commovente tenerezza. La provvidenziale asciuttezza, fornita in parte, a veder nostro, dai tagli che il regista ritiene proditori, mette in risalto le qualità più vere di De Santis; tra questa il "sentimento" che qui non scade mai in sentimentalismo.
Difetti? Alcuni, certo, dovuti, guarda il caso, a un eccesso di elaborazione [...]. Ma anche molti pregi: un'eccellente serie di riprese nel paesino tra Pescasseroli e Scanno, la buona recitazione di Pedro Armendariz, di Silvana Mangano e di Yves Montand [...]; e le sequenze degli appostamenti nel bosco. Una scena colpisce in modo particolare: l'arrivo di Montand, della Mangano e del bimbo nel paese abbandonato dopo il terremoto. Una menzione a parte merita la fotografia di Portalupi, il quale, soprattutto negli "esterni", ha usato il colore e il cinemascope con rara maestria.
Il bilancio di Uomini e lupi, la pellicola che il regista non vuole riconoscere come sua, viene a risultare, paradossalmente, del tutto positivo. C'è solo da augurarsi che De Santis, calmati i bollori, voglia considerare il "massacro" operato dai produttori come una pura e semplice "collaborazione al montaggio", e restituisca la sua firma a un lavoro che noi, a dispetto delle lettere circolari e delle dichiarazioni della stampa, riteniamo essenzialmente suo». (Franco Berutti, "De Santis fra i lupi", "Settimo giorno", 2 marzo 1957, in Rosso fuoco. Il cinema di Giuseppe De Santis, a cura di Sergio Toffetti, Lindau, Torino 1997, pp. 397-398)
Note sulla selezione lupo di Carlo Gubetti
Recentemente il lupo ha fatto la sua spontanea ricomparsa nelle Alpi occidentali. Il ritorno di questo grande predatore restituisce all'ecosistema un importante fattore di equilibrio e indica un miglioramento complessivo delle condizioni del territorio, ma soprattutto evidenzia la capacità dell'ambiente di rigenerarsi autonomamente non appena l'uomo lascia spazio allo sviluppo di libere dinamiche naturali. Il ritorno del lupo rappresenta infatti un episodio felice che non è stato in alcun modo programmato o favorito da interventi diretti dell'uomo. Un episodio felice di cui possiamo gioire tutti: anche se pochissimi avranno l'avventura di vedere un lupo in libertà, inoltrarsi in un bosco sapendo di condividere lo spazio con una presenza selvaggia, portatrice di una diversità assolutamente altra, conferisce infatti a quei luoghi un fascino e una ricchezza di stimoli che avevamo dimenticato. E questo perché, oltre agli aspetti ambientali, il lupo coinvolge anche un livello emotivo e culturale, testimoniato dalla sua presenza in leggende, miti e nelle produzioni artistiche e culturali di tutte le epoche.
Le relazioni tra l'uomo e questa specie sono in effetti molto complesse e risalgono ad un periodo molto precedente allo stabilirsi di rapporti ravvicinati con altri animali. Le prime comunità tribali di raccoglitori-cacciatori svilupparono un forte senso di rispetto e di identificazione nei confronti dei lupi, abili cacciatori dai comportamenti – complesse relazioni sociali, cooperazione nella caccia e nell'allevamento dei cuccioli – straordinariamente simili a quelli delle società umane. Tale ammirazione diede origine a forme di culto e a rituali magico-iniziatici che si affermarono in diverse aree geografiche, e che in molte popolazioni primitive sono sopravvissute fino ad epoche recenti. Il lupo è infatti l'animale totemico di molte tribù di indiani d'America così come in molti culti sciamanici dell'Asia centrale e della Siberia. Ma con il prevalere di società di pastori caratterizzate da rigide strutture patriarcali presero il sopravvento forme di pensiero dualistiche: da una parte l'uomo con i suoi armenti e le terre disboscate e trasformate in pascoli, le prime città e le nuove divinità antropomorfiche; dall'altra il "fuori", la natura selvaggia da soggiogare e sfruttare, le antiche divinità e i lupi, non più ammirati cacciatori, ma temuti predatori delle greggi. Questo processo giunse a compimento con l'affermarsi della religione cristiana, che adottò il dio unico e maschile di tribù di guerrieri-pastori della Palestina e ribaltò in negativo le precedenti forme di culto demonizzando i riti e le divinità preesistenti. Dall'animale totemico per eccellenza – progenitore degli uomini e in cui lo sciamano o lo stregone si trasformava per entrare in contatto con la sfera del divino – nacque così la figura del lupo demoniaco, quello che sarebbe diventato il lupo mannaro, l'uomo in grado di trasformarsi in animale e viceversa. Gli effetti di questa demonizzazione si fecero sentire ancora pesantemente nel Cinquecento e nel Seicento, quando migliaia di streghe e lupi mannari vennero bruciati dall'Inquisizione.
Da oggetto di culto a creatura demoniaca, ha così origine quell'ambivalenza di passioni contrastanti, di amore e odio, che connota la presenza del lupo anche nel cinema. Già in Werewolf of London (Il segreto del Tibet, 1935) di Stuart Walker il protagonista è guidato dall'insopprimibile impulso ad uccidere le persone che più ama. Dal mondo dei lupi echeggia una sorta di richiamo della foresta primordiale che si rivolge al lupo che è in noi con la potente seduzione a cercare il soddisfacimento immediato delle pulsioni istintuali. È questo lo schema di fondo della lunga serie di film sull'uomo lupo (tra horror e parodia dell'horror), in cui il protagonista anela a vivere seguendo le proprie passioni, ma è inesorabilmente condannato alla sconfitta (un titolo emblematico in tal senso è L'implacabile condanna, 1961 di Terence Fischer). Un esito diverso si ha con Wolf – La belva è fuori di Mike Nichols in cui il lupo-Nicholson afferma positivamente la propria animalità. Come gli sciamani di un tempo, Nicholson acquisisce le qualità che la specie totemica possiede in misura rilevante, ma queste rimangono soggette alla sua volontà – se non al suo controllo di essere razionale – il che rende possibile un esito positivo: il lupo-Nicholson non reprime le sue passioni, distrugge chi lo tradisce e ama con tutte le sue facoltà potenziate. Ma il lupo non limita la sua presenza al cinema horror, e compie le sue incursioni attraversando tutti i generi, come mostra la selezione di opere presentata nel Panorama [Cinemambiente 1998], che comprende documentari, lungometraggi e cartoni animati.
Anche nei cartoon classici americani degli anni Trenta e Quaranta, apparentemente spensierati e divertenti, emerge la componente pulsionale del lupo: da Disney a Tex Avery il lupo dà espressione ad ogni sentimento forte e violento, è un lupo che «si muove come un pazzo per fame non solo di cibo, ma soprattutto di sesso», come dice Marco Giusti nella presentazione del suo Bloobcartoon Lupi. Un personaggio perdente ma non sconfitto, sempre vitale a rincorrere le linee di fuga del desiderio.
In Uomini e lupi (1956) di Giuseppe De Santis emerge la concezione del lupo nella cultura pastorale di un paese della Marsica: l'attenzione è qui tutta rivolta alle dinamiche sociali e ai valori della tradizione contadina, in cui la figura del "luparo" emerge quale personaggio autorevole e stimato da tutta la comunità.
Il documentario Wenn der Wolf kommt (Quando arriva il lupo, 1997) di Andreas Moser ci fa infine conoscere l'animale lupo immerso nello splendido paesaggio delle colline toscane, proponendo alcune riprese singolari – chi l'avrebbe immaginato che i lupi oltre ai bambini e alle cappuccetto rosse mangiano le mele? Anche in questo lupo in carne ed ossa possiamo riconoscere il lupo che è in noi, casi come i lupi di Disney, Freleng, Tashlin, Nichols, Jones, Giusti e Avery.
Il ritorno del lupo di Franco Mari e Cristina Del Corso
«È astuto, prudente, sanguinario e feroce ed insidia la selvaggina grossa fino al luogo ove è ricoverata. L'assalta poi alla gola e in un attimo la uccide e divora. Quando non ha fame è piuttosto timido e codardo». Quest'immagine del lupo è tratta da un testo scientifico dei primi decenni di questo secolo e riflette l'atteggiamento verso questo animale che si è tramandato nel tempo attraverso favole e racconti.
Questa paura atavica unita al fatto che veniva considerato "nocivo", in quanto sottraeva prede selvatiche all'uomo e danneggiava le sue greggi, nella realtà si è tradotta in un continuo e metodico sterminio del lupo sul territorio. Tagliole, fucili e bocconi avvelenati hanno portato questa specie alle soglie dell'estinzione. Mentre nel secolo scorso il lupo era presente su tutto il territorio nazionale, esclusa la Sardegna, nel primo Novecento è già scomparso dall'arco alpino, dove l'ultima uccisione certa è avvenuta nel 1921 nelle Alpi Marittime. Nel 1950 le lupare lo hanno eliminato definitivamente anche dalla Sicilia: questa diminuzione numerica e di distribuzione è proseguita fino alla fine gli anni Sessanta, quando la specie contava non più di un centinaio di individui, arroccati nelle zone più selvagge dell'Appennino centro-meridionale. Oltre alla persecuzione diretta, questi ultimi esemplari dovevano sopravvivere in un ambiente in cui le popolazioni di cervo, capriolo e cinghiale, loro prede potenziali, erano ormai estremamente ridotte ed esisteva ancora un certo sfruttamento del territorio montano da parte dell'uomo.
Gli studi scientifici condotti negli ultimi anni hanno fatto emergere la vera natura del lupo e il suo ruolo fondamentale per la conservazione dell'ecosistema. Esso si è rivelato un animale intelligente con complessi rapporti sociali e un branco organizzato secondo una precisa struttura, che mantiene e difende un proprio territorio. Al suo interno esistono due diverse linee gerarchiche, una maschile ed una femminile, ognuna dominata dall'individuo di rango superiore, maschio e femmina alfa, che si impongono sui rispettivi subordinati mediante comportamenti ritualizzati che tendono a limitare l'aggressività esistente tra i membri del branco. II formarsi di stabili rapporti gerarchici è importante per la riproduzione, infatti solo il maschio e la femmina dominanti si riproducono, e solo una sola volta all'anno. Questo garantisce al branco la cucciolata migliore dal punto di vista genetico e una sorta di autoregolazione delle nascite finalizzata ad impedire un'eccessiva densità della specie. I carnivori infatti, a differenza degli erbivori, sono in genere distribuiti con pochi esemplari su territori vastissimi. Ma come può avvenire a livello pratico questo controllo delle nascite? Com'è possibile che con tutte le femmine in estro si verifichi un solo accoppiamento? Per rispondere bisogna ragionare in termini di "preferenze sessuali": in anni di osservazioni nell'area faunistica del Parco d'Abruzzo si è potuto osservare che il corteggiamento dei maschi si rivolge esclusivamente verso la femmina migliore, e viceversa per le femmine. E il maschio alfa ovviamente reprime vigorosamente ogni tentativo di corteggiamento della femmina alfa da parte di altri maschi.
Tutto questo avviene nel mese di marzo e tra la fine di maggio e l'inizio di giugno la femmina alfa partorisce da 2 a 7 cuccioli. È però l'intero branco che si fa carico del loro sviluppo, portando ai cuccioli il cibo necessario sino a quando non sono in grado di prendere parte alla caccia. Sono in grado di adottare ed elaborare diverse strategie di caccia in base alla preda e alla situazione, questo rivela la loro intelligenza e fa emergere il ruolo fondamentale che il lupo riveste per mantenere l'equilibrio dell'ambiente. Individuate le potenziali prede, con una serie di attacchi viene isolato il soggetto più debole (solitamente animali anziani o malati), sul quale poi si concentrano gli attacchi. In questo modo il lupo svolge un'azione positiva di selezione della popolazione preda, favorendo la sopravvivenza dei più forti ed evitando, nello stesso tempo, il diffondersi di malattie. Impedisce inoltre l'eccessivo aumento degli erbivori che, se non venissero limitati, finirebbero per danneggiare il bosco impedendone lo sviluppo e la rinnovazione, con grave danno per l'ecosistema.
Gli studi condotti in Italia a partire dagli anni Settanta hanno messo in luce un lupo che, per mancanza di prede, si doveva adattare ad alimentarsi di rifiuti e che evitava ogni possibile contatto con l'uomo, smentendo così le credenze sulla sua presunta pericolosità. L'ululato poi non ha alcun significato minaccioso, come spesso si crede, ma è semplicemente uno dei sistemi di comunicazione che i lupi usano per segnalare la loro presenza e il possesso del territorio ad altri individui della specie. Questa caratteristica viene sfruttata dai ricercatori per verificare la loro presenza e consistenza in un'area, mediante una tecnica detta wolf-howling, si emettono degli ululati registrati, stimolando così la risposta di eventuali lupi presenti.
Grazie alle conoscenze sull'ecologia e sul comportamento del lupo emersi da questi studi e ad una mirata campagna di stampa, la sua immagine è stata rivalutata. Questo, congiuntamente al diffondersi di una nuova coscienza ecologica in tutto il paese, ha portato nel 1971 al decreto di protezione del lupo su tutto il territorio nazionale. In quel periodo, il progressivo abbandono della montagna da parte dell'uomo ha restituito ampi spazi alla fauna selvatica che ha iniziato a crescere in numero e distribuzione, grazie anche ai rilasci di cervi, caprioli e cinghiali effettuati dall'uomo a scopo venatorio e di ripopolamento. L'insieme di questi fattori ha determinato una condizione favorevole per la sopravvivenza della popolazione di lupi che ora può ricominciare ad aumentare e ad espandersi lungo tutto l'Appennino. Negli anni Ottanta la presenza del lupo si è consolidata nell'Appennino ligure, nel 1990 un esemplare viene avvistato nel Parco dell'Alta Valle Pesio in Piemonte, e nel 1992 viene effettuato il primo avvistamento di due esemplari nel Parco Nazionale del Mercantour in Francia. Intanto nelle Alpi orientali, vengono segnalati esemplari in Slovenia nei pressi del confine italiano. Attualmente alcuni animali sono presenti in provincia di Cuneo nel Parco dell'Alta Valle Pesio e nella Valle Stura, probabilmente itineranti tra la Francia e l'Italia, e in provincia di Torino nelle alte valli Chisone e di Susa. Il monitoraggio dei lupi è estremamente difficile: ricercatori, parchi, università, regioni e province sono impegnati in progetti di studio per arrivare a definire le migliori strategie di gestione compatibili sia con la protezione della specie che con la salvaguardia delle attività umane come la pastorizia.
Ora l'opinione pubblica vuole conoscere meglio questo predatore e tutto il suo mondo, ecco quindi il proliferare di articoli sulla stampa, un suo nuovo ruolo nel cinema (come non ricordare "Due calzini" di Balla coi Lupi!) e i documentari trasmessi in numerosi programmi televisivi che si occupano di natura. C'è però da sottolineare un'inesattezza riguardo quest'ultimo aspetto: per lo più vengono proposti splendidi filmati con immagini spettacolari, realizzati però principalmente in Nord America, mentre sono rari quelli girati in Italia. In questo modo viene comunicata una realtà ben diversa da quella italiana in cui, tranne poche eccezioni, non esistono condizioni di prede e territorio idonei alla formazione di branchi numerosi come quelli filmati in Nord America. In Italia il branco è generalmente formato dalla coppia con i piccoli che, se le disponibilità alimentari lo permettono, restano con i genitori, altrimenti sono costretti ad allontanarsi alla ricerca di nuovi territori. La disponibilità di nuovi territori porterà ad un ulteriore incremento della popolazione, che attualmente è stimata intorno ai 500 individui.
Non bisogna però dimenticare che questo ritorno può procurare problemi agli allevatori che non devono essere i soli a farsi carico di questa presenza. Ecco perché se da un lato è importante che vi sia, da tutte le parti interessate, la massima cooperazione per individuare ed attivare tutte le misure di prevenzione dei possibili danni al bestiame, dall'altra è l'intera collettività che deve farsi carico dei diversi aspetti di questo fenomeno.
Abbiamo in prestito questo mondo per i nostri figli, e tra i nostri compiti c'è anche quello di fare in modo che, nel rispetto degli interessi di tutti, anche loro possano un giorno ascoltare l'ululato dei lupi nelle notti d'inverno.
Franco Mari e Cristina Del Corso sono ricercatori impegnati nel progetto sul monitoraggio del lupo nella provincia di Cuneo.
Esplora per area tematica
Vedi tutti i film