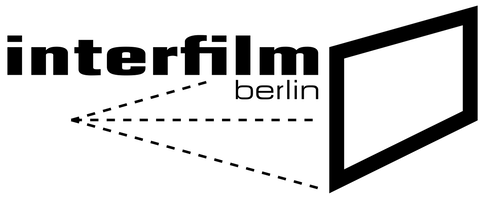La tragedia di un uomo ridicolo
Diretto da
Primo Spaggiari, industriale caseario la cui attività è prossima alla bancarotta, si trova a fare i conti con la scomparsa del figlio, rapito a scopo di estorsione. Per liberarlo i rapitori chiedono un miliardo. Quando il figlio viene dato per morto, l'imprenditore cerca di realizzare un piano truffaldino per salvare il proprio caseificio... Ambientato nella Bassa Padana, un film pieno di ambiguità e dai molteplici registri: senza soluzione di continuità Bertolucci innerva in una storia drammatica momenti di pura ironia e umorismo, realizzando un'opera interlocutoria. Tognazzi, nei panni di un imprenditore di provincia, definisce un ritratto acuto e sconvolgente della mediocrità italiana.
Approfondimento
A proposito di Tragedy of a Ridiculous Man
Il cinema corre sul fiume di Sergio Toffetti
Quando nasce il Neorealismo? La domanda arrovella quasi tutte le storie del cinema italiano, che finiscono per tratteggiare alberi genealogici variamente ramificati, come quello della storiografia “postresistenziale” che con rigorismo più politico che estetico rifiutava in blocco tutto il cinema girato sotto il fascismo come mera espressione del regime, salvando i famosi "quattro padri del neorealismo": I bambini ci guardano di Vittorio De Sica, Quattro passi tra le nuvole di Alessandro Blasetti, Uomini sul fondo di Francesco De Robertis con la collaborazione di Roberto Rossellini e Ossessione di Luchino Visconti. In anni più recenti le pertinenze familiari si allungano radicandosi nel cinema muto e si allargano al recupero di una moltitudine di parenti collaterali (da Mario Camerini, al cinema dialettale di Aldo Fabrizi, fino al "calligrafismo" di Poggioli, Soldati, Castellani, talvolta riletto in chiave di rifiuto dei miti di regime).
Insomma, come tutti i movimenti artistici che mantengono la loro vitalità, anche il Neorealismo si allarga e si restringe, a seconda del paradigma critico impiegato (al cinema il problema è infatti sempre la scelta del "punto di vista"), quasi continuasse a "respirare" con noi.
La nostra retrospettiva, che in una sorta di viaggio d'esplorazione intreccia le vicende del cinema italiano con il corso del fiume Po, ci suggerisce ora una domanda di tipo differente: non “quando”, ma "dove" nasce il Neorealismo? E la geografia sembra suggerire una scorciatoia per sciogliere le complessità della storia: il Neorealismo nasce sul Po.
"Vorremmo una pellicola avente a protagonista il Po e nella quale non il folklore, cioè un'accozzaglia di elementi esteriori e decorativi, destasse l'interesse, ma lo spirito, cioè un insieme di elementi morali e psicologici, nella quale non le esigenze commerciali prevalessero, ma l'intelligenza”. Così scrive nel 1939 su "Cinema" Michelangelo Antonioni, in un articolo significativamente intitolato Per un film sul fiume Po, precisa dichiarazione di poetica, quasi un'introduzione scritta a quell'ideale cartografia visuale che, prendendo le mosse quattro anni dopo con Gente del Po – il suo primo documentario – condurrà il regista a esplorare l'intero corso del fiume, da Torino a Ravenna: dal pavesiano Le amiche (1955), al Grido (1957), a Deserto rosso (1964). L'articolo di Antonioni si inserisce con forza nel dibattito sul "nuovo paesaggio" che, nei primi anni '40, anticipa sulle pagine delle riviste il rinnovamento del cinema italiano, e che due anni dopo fa scrivere a Giuseppe De Santis: "Come sarebbe possibile intendere e interpretare l'uomo, se lo si isola dagli elementi nei quali ogni giorno egli vive, siano essi ora le mura della casa... ora le strade della città... ora il suo inoltrarsi timoroso, il suo confondersi nella natura che lo circonda e che ha tanta forza su di lui da foggiarlo a sua immagine e somiglianza" (Il paesaggio italiano, "Cinema”, aprile 1941). Il paesaggio – dice ancora De Santis – è l'elemento più ricco di immediatezza e di comunicatività agli occhi dello spettatore "Il quale, anzitutto, vuole vedere”. Le analisi di De Santis e di Mario Alicata, nate pensando soprattutto al paesaggio dei Malavoglia che, fino alla Terra trema costituirà il "soggetto d'elezione” del gruppo di "Cinema" [1], sono destinate invece a incarnarsi in un corpo filmico proprio in quei paesaggi della bassa padana trasformati da Luchino Visconti, per il suo esordio con Ossessione (1943), in una terra di desolata e struggente bellezza, mappa fotografica dell'inquietudine sociale ed esistenziale che rompe la crosta del superficiale perbenismo di regime.
Se infatti si sospendono le ragioni della filologia per privilegiare l'emozione che ci cattura dal primo fotogramma di Ossessione, si intuisce immediatamente che con l'esordio di Visconti non solo comincia davvero il Neorealismo, ma il cinema italiano entra nella modernità, grazie alla ricerca di un paesaggio concreto da opporre alla neutralità scenografica del cinema di regime, paesaggio che viene riletto con uno sguardo alla confluenza tra il naturalismo di Jean Renoir e Marcel Carné (sui set dei quali Visconti muove i primi passi), e le atmosfere noir del romanzo di James Cain che sta alla base del film, Il postino suona sempre due volte. Uscito in contemporanea con film, anche notevoli, come Il birichino di papà di Matarazzo, Giacomo l'idealista di Lattuada, L'uomo dalla croce di Rossellini, Ossessione apre un'improvvisa finestra su un mondo diverso: i canali, le nebbie, il sole a picco, i balli all'aperto, la striscia d'asfalto che corre sull'argine, le biciclette, i camion, e ancora l'erotismo senza l'alibi dell'amore, maschi sudati in canottiera, donne in sottovesti attillate, sguardi di desiderio, delitti d'amore e cupidigia, un larvato riferimento alla guerra di Spagna e addirittura un'esplicita relazione omosessuale, tanto scandalosa da venir censurata anche dalla critica di sinistra del dopoguerra che, semplicemente, la ignora [2].
Sul Po termina anche il “viaggio in Italia” condotto da Roberto Rossellini con Paisà, lasciandoci negli occhi e nel cuore le immagini dei corpi dei partigiani portati dalla corrente con al collo il cartello "Banditen”. Tra il 1942 e il 1947 dunque, sulle stesse rive si affacciano Antonioni, Visconti, Rossellini e il De Santis di Caccia tragica (1946), a coprire quasi l'intero arco di posizioni autoriali che definiscono il cinema nuovo. D'allora la Valle del Po, nel cinema, tornerà spesso a essere scenario della storia, ambientazione privilegiata di molti film sul fascismo e sulla Resistenza, da quelli girati quasi in presa diretta sui fatti, alle riflessioni successive, da Gli sbandati (1955) di Francesco Maselli a La lunga notte del '43 (1960) di Florestano Vancini, dal Processo di Verona (1962) di Carlo Lizzani, al Terrorista (1963) di Gianfranco De Bosio, al Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, dai Sette fratelli Cervi di Gianni Puccini (1968) a L'Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo.
Ha dunque ragione Jean Renoir, a vedere nella corrente del fiume il modello fisico del cinema. II fiume: liquido nastro d'acqua che scivola rispecchiando la vita. Quasi una metafora del cinema: all'origine "film" che nella macchina da presa scorre nel tentativo di cogliere i riflessi del reale; "pellicola”, che può prendere davvero forma soltanto immergendosi allo sviluppo in un bagno chimico per sfociare, finalmente, nelle immagini in proiezione sullo schermo, dopo essersi aperta la strada, come tra i gorghi, attraverso gli ingranaggi del proiettore.
E in particolare il cinema italiano, come in un gioco di specchi tra finzione e realtà, fin dalle origini accompagna il corso del Po dalle sorgenti alla foce, raddoppiandone il flusso con una corrente di immagini. La Bassa, le risaie, Ferrara, il Delta e Torino, che la nascente industria cinematografica trasforma negli anni Dieci in una sorta di "Hollywood sul Po”, sono il paesaggio delle stagioni della nostra storia recente: le lotte contadine, le guerre, il Fascismo, la Resistenza, il boom economico, ci fanno venire in mente altrettanti titoli che hanno segnato la nostra educazione cinematografica. Ma anche le cronache minute delle tradizioni e dei mestieri che scompaiono. E le atmosfere. Gli autunni nebbiosi, i sapori di un tempo che sembra ieri, ma è già lasciato indietro dalle trasformazioni economico-sociali.
Ai tempi del muto, il Po è presente quasi soltanto come set: astratta figura d'acqua funzionale, indifferentemente, a ospitare le navi in fiamme del dannunziano Sogno di una notte d'autunno di Luigi Maggi (Ambrosio, 1911), ad attenuare la caduta finale di Ernesto Vaser, vanesio protagonista della comica La moda vuole l'ala larga (Itala Film, 1912), o a fungere da sfondo per Gli ultimi giorni di Pompei di Luigi Maggi. Vent'anni dopo, in Addio giovinezza, diretto nel 1942 da Ferdinando M. Poggioli dalla pièce teatrale di Nino Oxilia, il fiume si conferma invece come segno metonimico di Torino, quasi il riflesso orizzontale della verticalità della Mole Antonelliana. Come del resto, la Mole e il Po, racchiusi nella stessa inquadratura, concepita con l'olografica fissità della cartolina ricordo, tornano più volte a mo' di siparietto per segnare il passaggio dalla campagna alla città del giovane Macario accompagnato dal fido Carlo Campanini in Lo vedi come sei? (1939) di Mario Mattoli.
Nel dopoguerra, sull'orizzonte della pianura, il fotoromanzo epico delle mondine belle ed inquiete come Silvana Mangano in Riso amaro (1948) di Giuseppe De Santis ed Elsa Martinelli ne La risaia (1955) di Raffaello Matarazzo, si intreccia con il romanzo storico: da Il mulino del Po di Riccardo Bacchelli, portato sullo schermo nel 1948 da Alberto Lattuada, alla versione de La Certosa di Parma diretta da Mauro Bolognini nel 1982. Ma echi lontani del romanzo di Bacchelli li ritroviamo anche, per quella funambolica capacità degli sceneggiatori d'epoca di pescare nella grande letteratura del passato riutilizzandone con disinvoltura brani, episodi, scene, caratterizzazioni [3], nel melò sentimentale La donna del fiume (1954) che Mario Soldati dirige su commissione di Carlo Ponti per lanciare la nuova star del cinema italiano: Sophia Loren, cui sicuramente guarda, in un singolare gioco di corrispondenze, Alberto Bevilacqua nel tratteggiare Romy Schneider in La califfa (1970).
Lungo la valle del Po Mario Soldati porterà nel 1957 la neonata televisione a registrare insieme alle ricette dei cibi genuini, i gesti quotidiani della gente della valle del Po, quasi anticipando il grande affresco di vita contadina tratteggiato da Ermanno Olmi in L'albero degli zoccoli (1977), che nel 1995 scende a girare un incantato viaggio intitolato per l'appunto: Lungo il fiume.
Il Po e le contraddizioni sociali che ne agitano le sponde fanno da sfondo al documentarismo politico degli anni '50, con film, tra molti altri, di Vancini (Delta padano, 1951), Gillo Pontecorvo (Operazione Timiziazev, 1953), Renzo Renzi (Quando il Po è dolce, 1955). Anche se l'orizzonte di questo "cinema padano" non resta confinato alla sfera sociale, ma trasforma la grande pianura in territorio aperto alla deriva delle emozioni. Come nel caso di Michelangelo Antonioni, forse con Bernardo Bertolucci il cineasta più a lungo fedele al suo paesaggio originario, che vorrà ritrovare Ferrara anche per il suo ritorno al cinema, dopo lunghi anni di sostanziale inattività e una grave malattia, con Al di là delle nuvole nel 1995. Ed è certo per una sorta di "omaggio" ad Antonioni, che Ferrara finisce per diventare una delle città meglio filmate d'italia, trasformandosi in set per registi come Mario Monicelli (Temporale Rosy, 1979), Marco Ferreri (Il futuro è donna, 1984), Florestano Vancini (Amore amaro, 1984), Giuliano Montaldo (Gli occhiali d'oro, 1987), Carlo Mazzacurati (Notte italiana, 1987), Ermanno Olmi (Il mestiere delle armi, 2000).
Nella Valle del Po, tra Piacenza e Parma, esordiscono ancora, nel primi anni '60, i due massimi esponenti della "nouvelle vague all'italiana”, Marco Bellocchio e Bernardo Bertolucci che nei loro film "padani" come, rispettivamente, I pugni in tasca (1965) e La Cina è vicina (1967) e Prima della rivoluzione (1964), La strategia del ragno (1972), La tragedia di un uomo ridicolo (1981) sembrano a tratti pescare negli umori grotteschi e surreali che condividono i due numi tutelari del Po: Giovanni Guareschi e Cesare Zavattini, apparentemente divisi sul piano superficiale degli schieramenti politici, ma, proprio come Peppone e Don Camillo, profondamente intrisi di quel paesaggio che Guareschi così descrive nell'introduzione al primo Don Camillo (1952) di Julien Duvivier: "Nebbia densa e gelata l'opprime d'inverno, d'estate un sole spietato picchia martellate furibonde sul cervelli della gente, e qui tutto si esaspera”.
Mentre l'influenza di Zavattini si fa sentire in opere caratterizzate da una sorta di minimalismo "post-neorealista”, come Un ettaro di cielo (1959) di Aglauco Casadio con Mastroianni nella parte di un simpatico imbroglione che vende "ettari di cielo a poveri zavattinianamemte "matti”, e Scano Boa (1961) di Renato Dall'Ara, interessante sguardo di taglio semidocumentaristico sui pescatori di storione del delta padano tratto dal romanzo di Gian Antonio Cibotto (ma in fondo anche Domani accadrà diretto da Daniele Luchetti nel 1997 avrà un versante implicitamente zavattiniano), a distanza di tempo, nasce spontaneo un confronto tra la saga di Peppone e Don Camillo e il grande affresco di Bernardo Bertolucci in Novecento (1975). È vero che Alfredo Berlinghieri (Robert De Niro) e Olmo Dalcò (Gérard Depardieu) vivono l'intreccio tra la loro amicizia e i conflitti di classe non solo con la consapevolezza di trovarsi al cospetto della storia, ma addirittura rileggendone i riflessi nel loro inconscio, mentre Guareschi e i cineasti che portano sullo schermo il "piccolo mondo" di Brescello giocano il cronachismo bozzettistico delle schermaglie tra il prete impersonato da Fernandel e il corpulento sindaco comunista di Gino Cervi in tono minore. Ma l'ostentato populismo anti-intellettualistico di Guareschi, unito all'ostinato coraggio che, nella vita, lo porta in carcere per alcuni mesi, denunciato da Alcide De Gasperi per diffamazione, finiscono per infilare – e ci si chiede come la censura l'abbia passato – le uniche immagini documentaristiche che appaiono in un film a soggetto della drammatica alluvione del Polesine dell'inverno ‘51/’52 nel Ritorno di Don Camillo (1953) di Duvivier, e cosa ancora più azzardata per l'epoca, l'unico riferimento esplicito ai morti di Reggio Emilia negli scontri di piazza contro il governo Tambroni del luglio 1960 in Don Camillo monsignore ma non troppo (1961), forse grazie agli sceneggiatori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi.
Sarà merito della corrente del fiume, ora torbida e impetuosa, ora limpida e calma, che da sempre trascina a valle, ai bordi, lungo le sponde, estri, simboli, residui dell'immaginario e del quotidiano, per cui Pupi Avati può riprendere nel suo personale percorso cinematografico gli umori di Guareschi in film come La casa dalle finestre che ridono (1976) o Le strelle nel fosso (1979), e addirittura Luciano Ligabue torna a Brescello per girare Radiofreccia (1998).
Quasi a confermare le corrispondenze tra il paesaggio del Po e il cinema della modernità, a girare sul fiume tornano Franco Piavoli col Pianeta azzurro (1981), Gianfranco Mingozzi con La vela incantata (1982), e innumerevoli altri, anche i più inattesi, come Nanni Moretti, che in Aprile (1998) documenta la discesa dei leghisti lungo il Po fino a Venezia per versare nell'Adriatico l'ampolla d'acqua raccolta alle sorgenti del fiume sul Monviso; o come Raffaele Andreassi che, ne I lupi dentro (2000) riprende un suo personalissimo dialogo con l'immaginario del pittore Ligabue (che Flavio Bucci aveva per altro impersonato in una biografia di taglio televisivo diretta da Salvatore Nocita nel 1978).
Dopo la grande saga di Bertolucci in effetti, sul Po sembra essersi ristretto lo spazio per la "Storia". Il fiume ritorna a porsi come un semplice segno geografico, individuato nel film di Attilio Concari sceneggiato da Davide Ferrario, come una linea sulla mappa, il 45° parallelo (1985), anche se forse, con le trame intricate della sua Notte italiana, Carlo Mazzacurati si preoccupa di ricordarci che ciò che chiamiamo "cronaca" è già la storia colta nel momento in cui capita.
O almeno: un'altra delle tante storie accadute lungo un fiume, il Po, che come dice Cesare Zavattini: "uno si porta addosso come un vestito”.
[1] Considerati un po' troppo "acerbi" dai detentori dei diritti del capolavoro di Verga, i "viscontiani" di "Cinema”, De Santis, Alicata, Gianni Puccini, Pietro Ingrao ripiegheranno sui racconti, abbozzando soggetti e sceneggiature da L'amante di Gramigna a Rosso Malpelo. La sceneggiatura originale di L'amante di Gramigna, redatta da Giuseppe de Santis e Luchino Visconti, con annotazioni e schizzi autografi di Visconti, è conservata nel Fondo de Santis del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che conserva anche alcune lettere inviate nel 1942 da Pietro Ingrao a De Santis sul set di Ossessione, facendo precisi riferimenti al lavoro di sceneggiatura da lui svolto per una trasposizione cinematografica di Rosso Malpelo.
[2] Il primo a leggere in termini di rapporto omosessuale l'incontro tra Gino (Massimo Girotti) e lo Spagnolo (Elio Marcuzzo) é Yves Guillaume in Luchino Visconti, Parigi, Presses Universitaire, 1966, seguito da Geoffrey Nowell-Smith in Luchino Visconti, London, Secker & Warburg, 1967. Tra i critici italiani, il più coraggioso era stato in precedenza Guido Aristarco che scrive, nelle note di commento alla sceneggiatura di Rocco e i suoi fratelli (Bologna, Cappelli, 1960): "alcuni atteggiamenti dello Spagnolo restano ambigui, soprattutto sul piano dei sentimenti che lo legano a Gino”.
[3] Basti pensare alla trasformazione che Luciano Vincenzoni fa di due personaggi di Maupassant in Alberto Sordi e Vittorio Gassman della Grande guerra di Mario Monicelli.
Media Download
Poster
Esplora per area tematica
Vedi tutti i film