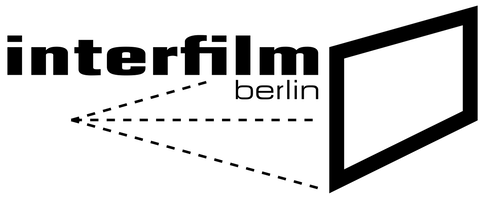2019 – After the Fall of New York
Diretto da
Dopo una terribile guerra nucleare, sulla Terra i superstiti si dividono in due gruppi: i temibili Euraks e la Federazione Ribelle. Un mercenario chiamato Parsifal viene assoldato dalla Federazione per compiere una pericolosa missione: penetrare in New York – città in mano agli Eurkas – e portare in salvo l'unica donna rimasta fertile.
Approfondimento
A proposito di 2019 – After the Fall of New York
(Post) Apocalypse Now: Il cinema dopo la fine del mondo di Fabio Pezzetti Tonion
Capace di dare una forma tangibile e di rendere concreta l'angoscia paralizzante dell'incubo atomico, il cinema si è sempre confrontato alla radice con il problema della rappresentabilità di quella paura. Il mostrare la catastrofe, da questo punto di vista, non era altro che il momento di massimo, inevitabile e conclusivo climax a cui il film doveva giungere: in una prospettiva in cui l'esito finale del film era condizionato, ciò che interessava davvero era l'incombere della minaccia, l'angoscia del tempo che correva inevitabile verso la distruzione ultima, definitiva. La conclusione era già data: tangibile manifesto di un'epoca scossa dalla guerra fredda, la catastrofe finale era quella che chiudeva (almeno metaforicamente) ogni film che cercava il confronto con l'urgenza di un tema scottante come quello dello scontro tra superpotenze. II cinema non era strumento consolatorio, luogo di facile evasione e divertimento. Impressa sullo schermo, la prospettiva dell'annientamento totale acquistava i tratti di un'oscura profezia che in cuor suo ogni spettatore temeva si avverasse, poiché sul presente pesava l'idea di un futuro senza vie d'uscita, irrimediabilmente condannato. E allora comprensibile come in questa idea di cinema (un cinema che potremmo definire della "catastrofe") ciò che ha valore è l'hic et nunc dell'azione: il film definisce un presente che è quello in cui si vive e che è specchio della società e dei suoi umori. Non c'è spazio per un dopo: l'idea di un futuro è naturalmente bandita, poiché se la distruzione nucleare è totale, come potrebbe esserci ancora futuro?
E questa la domanda (quale sarà il futuro dopo la fine del mondo?) che in maniera più o meno esplicita ed efficace si pongono i film che la sezione Late Night Show propone in questa edizione del Festival [CinemAmbiente 2004]. A partire dagli anni Sessanta e dalla fantascienza inglese de E la terra prese fuoco, passando per l'esordio dietro la macchina da presa di Ray Milland (Il giorno dopo la fine del mondo), per arrivare – vent'anni dopo e in un clima ideologico mutato – a film dal valore ambiguo e diseguale come The Day After e 2019: dopo la caduta di New York, ci troviamo di fronte a opere che non solo sono capaci di confrontarsi con questo interrogativo, ma che sono anche un eloquente sintomo del mutato atteggiamento nei confronti della rappresentazione della distruzione atomica, espliciti testimoni del passaggio dal cinema della catastrofe, al cinema della post-catastrofe. Dunque film post-apocalittici. Ma, pur indagando aspetti inediti di un futuro carico delle angosce dell'oggi, non riescono ad affermare un nuovo statuto dello sguardo, capace di andare oltre i film della stagione "ideologicamente" precedente: ciò che dimostrano in realtà è che lo sguardo del cinema (e con esso lo sguardo dello spettatore e dunque, in ultima analisi, lo sguardo dell'uomo) non può osservare il cuore nero dell'abisso: come (di)mostra Akira Kurosawa nella straordinaria sequenza in cui l'anziana protagonista di Rapsodia d'agosto ricorda l'esplosione dell'atomica su Nagasaki, è l'abisso un occhio immenso e malvagio spalancato nel cielo a guardare, a guardarci. Siamo muti e impotenti, oggetti visti, non vedenti. Evidente metafora della nostra impossibilità della visione, il cinema sembra continuare a essere incapace di oggettivare il momento della devastazione totale. Questo momento, questo climax nullificante, continuamente evocato, e prefigurato, è sempre interdetto allo sguardo: anche quando è presente (come nel celebre finale de Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick) ciò che lascia è una sensazione di impotenza: l'impotenza di mostrare fino in fondo l'orrore. Si è sempre distanti, davanti agli occhi c'è sempre un velo che rende la percezione ottusa e incompleta e il cinema, di fronte all'angoscia del momento della distruzione atomica, non può che limitarsi a rappresentare il prima e il dopo di quel momento: parafrasando Marguerite Duras, si può dire che tutto quello che il cinema può fare è mostrare l'impossibilità di mostrare Hiroshima. Perché non si può mostrare il nulla, ma solo gli attimi che lo precedono o lo seguono.
Confermandosi come la sezione rivolta alle frange più cinefile del pubblico del Festival, Late Night Show attraversa alcuni momenti emblematici del cinema della post-catastrofe passando senza apparente soluzione di continuità, dal grande cinema d'autore, a film italiani di genere, per giungere alle produzioni di serie B americane e inglesi, seguendo un percorso cronologico che potrebbe (almeno idealmente) essere aperto e chiuso da due opere emblematiche: Hiroshima mon amour (1959) e Lo stato delle cose (1982). Emblematiche in quanto riescono a dare la misura del cambiamento della rappresentazione della tragedia. Il film di Resnais è il primo grande film della post-catastrofe e non solo indaga nella carne viva della vergogna di un atto disumano e disumanizzante, ma sancisce con lucidità sconcertante l'impossibilità di mostrare quella vergogna: ciò che resta è un ricordo, una memoria distorta dal tempo che non darà mai la misura di ciò che è stato l'orrore di Hiroshima. Quasi un quarto di secolo dopo, Wim Wender chiude il cerchio, in un'opera complessa e stratificata che inizia presentando le immagini di un film sui sopravvissuti a un disastro atomico. Un film nel film (intitolato appunto The Survivors, I sopravvissuti) in corso d'opera, realizzato tra mille difficoltà e che non sarà mai concluso: in un'amarissima e spietata riflessione sul cinema e sulla morte (sulla morte nel cinema/del cinema), il regista tedesco non fa altro che confermare il limite di “infilmabilità” della catastrofe: in questa prospettiva Lo stato delle cose non è altro che la testimonianza dell'incapacità dell'uomo di vedere fino in fondo (la morte del regista Fritz nel finale non fa che ribadirlo). Si è sempre ai margini del momento essenziale e lo sforzo che il cinema fa per penetrare questa essenzialità è, sempre e comunque, frustrato. Ciò che resta, alla fine, è il paesaggio surreale in cui Kurosawa ambienta due episodi del suo Sogni: non si può invocare la realtà del cinema, bisogna andare oltre, nella dimensione d'incubo realizzata dal maestro giapponese. E lì, in quella tenebra allucinata, in quell'oltre del cinema verso cui pochissimi hanno saputo spingersi, che sta il cuore della nostra impossibilità (della nostra paura) di vedere.
Media Download
Poster
Esplora per area tematica
Vedi tutti i film